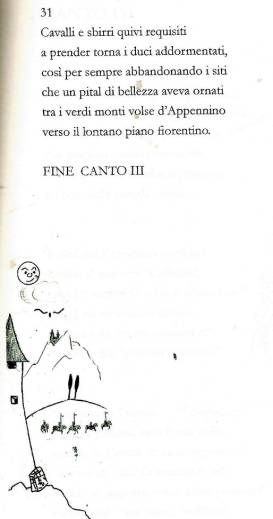2018
- Le mie nuove Recensioni
INDICE
1)Premessa
2)Leily (anni 12), Gruppo Gold La prima
avventura
3) Claudio Papini, Il segretario &
il suo doppio-
(Niccolò Machiavelli & Cesare
Borgia)
4) Giulio Vignoli, Repubblica italiana-
Dai brogli e dal colpo di stato dal 1946 ai giorni nostri
- Digressione di M.L. Bressani sul libro
di Hayward Storia della Casa di Savoia,1955,dono per me nel 1961-.
5) Ricordo del prof. Enrico Turolla
6) Emilio e Maria Antonietta Bigini, Le
più brutte storie
7) Salvatore Satta, Mia indissolubile
Compagna
8) Salvatore Satta, Padrigali mattutini
9) Giovanni Meriana, Sono partiti tutti-
Ultimi giorni di Reneusi e altre storie
10) Giglio Reduzzi, E’ arrivata la
svolta
- Il Paese che vorrei
11)Giovanni Ferrero, Chicco, Gli
“Zoccoletti”- Ricordi di Casa Ferrero (1851/2001)
12) Maria Clotilde Giuliani – Lettera
per l’autore sul libro
13) Fabio Capocaccia – Lettera per
l’autore sul libro
14) Silvio Vignetta, Una lunga vita
15) Grazia Zerbi, L’affresco
16) Grazia Zerbi, Agnese e i continenti
17) Laura Boschian, moglie di Salvatore
Satta: Diari di una triestina
18) Maria Rosaria Dominis, Gli Oleandri
di Dubrovnik
19) Cesare Quadri, La Senaide
Premessa
Quando scrivo una recensione sono convinta che
quanto è detto nel libro sia da contestualizzare nel tempo in cui si verificò,
ammesso che l’autore non l’abbia già fatto e talvolta in modo da sorprenderci.
Quanto s’impara dai libri...!
Ecco quindi questa nuova serie di recensioni che
metto su questo mio Sito non collaborando più a giornali dal giugno del 2013.
(Chi vuole può vedere le precedenti a Recensioni
e non solo (gli si aprono 25 pagine
tematiche con
articoli
tutti pubblicati) su http://mlbressani.wixsite.com/marialuisabressani)
Queste mie nuove, del 2018, riguardano libri
ricevuti in dono da miei estimatori (lo spero) nello scorso Natale e non avendo
un giornale su cui collocarle le ho messe su questo nuovo Sito, nato
principalmente a tal fine. Dai libri ricevuti ho imparato sentendomi più in amicizia
con gli autori, pur restando il diritto di critica.
Preciso, poiché c’è stato un tempo (anni settanta)
in cui il critico usava le recensioni come un palcoscenico personale e metteva
in secondo piano l’autore, che cerco invece di dar risalto a ciò che pensa e al
perché ha scritto il libro.
Una critica a me stessa: sono recensioni lunghe, ma
sai che libertà a non esser condizionata dal numero di righe come quando si
scrive sui giornali.
Un’avvertenza: i miei
commenti tra una recensione e l’altra saranno da me scritti in rosso
(così chi preferisce li può saltare per andare alla recensione successiva
oppure li vedrà meglio se desidera leggerli).
Gruppo Gold
La prima
avventura
di Leily (anni 12)
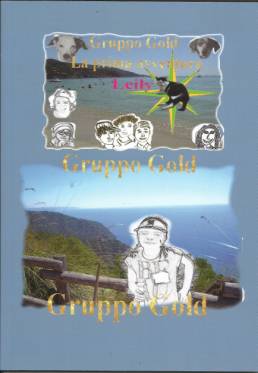
Questo delizioso primo libro è stato scritto da una
ragazzina di 12 anni (con la collaborazione del papà).
La dedica è: “alla mia mamma, che era una grande
lettrice” e conclude con un “Buona lettura!”
Sono 56 agili pagine (lo troverete anche online)
con qualche figura come la seguente dove Leily ha designato i protagonisti
maschili della storia.
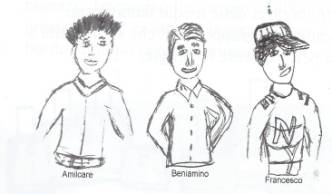
Il gruppo d’amici, costituito in parità dai tre
ragazzi sopra disegnati e da tre ragazze più due cani Gen e Hallie, è alla
ricerca di un tesoro come succede proprio nei libri che leggevamo quando
avevamo la loro età. Non manca la casa del tesoro, ormai in abbandono dei coniugi Gold che vi avevano abitato e, guarda caso, erano stati scrittori di
libri d’avventure con tema comune “tesori da ritrovare”. Scrittori diventati
famosi al loro tempo come fa fede un articolo di giornale rinvenuto dai piccoli
esploratori.
Il gruppo di ragazzini prende il nome dei coniugi
Gold (e quale sarebbe più appropriato per la ricerca di un tesoro?), come
altrettanto interessanti sono i nomi dei loro accompagnatori: il cane Gen,
diminutivo di Generale, e la cagnolina Hallie cui la padroncina ha voluto dare
il nome della sua sorellina gemella, adottata da un’altra famiglia poco prima
di lei.
La storia inizia in quel luogo incantato e
noto per le vacanze che è la nostra
isola d’Elba ma si sposta dal Mar Mediterraneo all’Oceano Atlantico a Capo
Verde dove i coniugi Gold avevano avuto una casa. Questo accade quando i genitori vengono convinti dai ragazzi a
spostarsi là per l’idea sempre più plausibile per tutti loro, in base a
ritrovamenti vari, che un tesoro esista davvero.
Nel dipanarsi della storia, senza fronzoli, con un
linguaggio essenziale, non mancano infortuni vari dalla ragazzina che si sloga
una caviglia al ragazzino che nella traversata cade in mare dal catamarano.
Inserisco dal libro un disegno di Leily dove ha
disegnato con precisione la rosa dei venti.
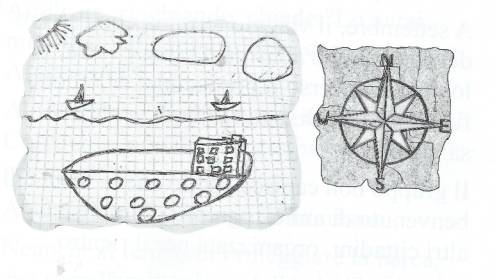
Un aspetto di questo primo libro, incantevole nella
sua freschezza, è la conoscenza di cose molto tecniche e attuali come la
citazione di GPS, telefonini, metal detector, trasmettitore nautico e non manca
la cassetta del pronto soccorso. Per questa posso immaginare ci sia stato il contributo del papà per insegnarle che
anche nella più semplice gita (e queste dei ragazzi sono state “gite” piuttosto
avventurose) può accadere l’imprevisto per cui è meglio premunirsi con qualcosa
che possa servire ad un’immediata medicazione.
Non solo, c’è un importante elemento di educazione
civica quando l’ipotesi di ritrovare il tesoro si fa sempre meno campata in
aria e i ragazzi vengono avvertiti dai genitori che dovrà essere consegnato ai
Carabinieri perché esso non appartiene a loro ma allo Stato. E sull’onda della
nostra attualità c’è perfino il soccorso in mare ad un barcone di profughi.
Non mancano momenti di humour come quando, a Capo
Verde, Amilcare uno dei tra ragazzi che non sa lo spagnolo ma per far
colpo cerca di parlarlo, aggiunge
sempre una “s” finale alle parole. Perciò i compagni lo soprannominano
Amilcares.
Non so immaginare se Leily in futuro ricorderà
questo libro come un qualcosa di bello da lei portato a compimento quando si
leggono libri che gli adulti hanno scritto per i ragazzi mentre lei ha saputo
farne uno in prima persona. Per questo lo ricorderà volentieri pur se forse non
continuerà più a scrivere. Però è proprio a questa età che nascono le
“vocazioni” e può essere che la scrittura diventi per lei uno scopo. Potrà
anche essere una scrittura scientifica, per divulgare e spiegare fatti
scientifici ed invenzioni tecniche poiché si nota nel libro un suo interesse di
questo genere. C’è soprattutto da parte di Leily un tratto della sua
sensibilità, della sua acutezza di spirito, che le ha fatto cogliere come
durante il sonno, attraverso i sogni, veniamo a dipanare con più chiarezza cose
che ci sono successe durante il giorno ed a trovare qualche soluzione. Infatti
è nel sonno che questi ragazzini capiscono meglio il significato di ciò che
hanno vissuto o visto di giorno.
Nell’indice del libro il capitolo finale s’intitola “Delusione” perché come in un
giallo alla Agatha Christie questo svelerà se il tesoro esiste davvero o no.
Non vi tolgo la suspense e invito a scaricare il libro online (mezzo moderno di
comunicazione) perché le copie in carta sono state poche.
Anzi, mi sento onorata di averne ricevuta una con
la dedica “con simpatia a Marisa”, che è il mio nome in famiglia.
E’ stato al momento della benedizione pasquale
delle case che don Vincenzo, sacerdote della nostra parrocchia, cara al
Cardinal Siri (un tempo ne ho anche scritto), arriva a compiere sempre dopo la
festività. Ma questa benedizione è davvero un momento intenso perché si fa con
la preghiera in comune sul pianerottolo. Questa volta a noi e alla nostra
vicina di ballatoio Jole, da poco vedova, si sono aggiunti anche Leily e il suo
papà scendendo dal piano di sopra. Non è da molto che sono venuti ad abitare
qui e quando don Vicenzo ha precisato che Leily è così brava per merito non
solo dell’educazione del suo papà ma anche della sua mamma, mancata di recente,
Leily ha abbassato il capo e i suoi
occhi si sono fatti lontani e scuri di commozione profonda.
Sì la vita non è facile ma scrivere un libro è
sempre una grande risorsa. E’ terapeutico anche se non vi si scrive nulla di
ciò che ci riguarda: ci distrae e ci dà uno scopo finché non lo abbiamo portato
a compimento. Come scrisse una grande scrittrice Natalia Ginzburg nel suo Le
piccole virtù, per quel lavoro
fatto bene si può stare in piedi la notte.
Auguri Leily per continuare a crescere come mamma
ti vorrebbe.
Grazie per questo dono che hai fatto a me in
particolare ma a tutti coloro che avranno la fortuna di leggerti. Ti abbraccio
forte come ho fatto una volta con una nipotina della tua età quando si volse
verso di me scoppiando a piangere al funerale della sua mamma. Già sei anni da
allora perché la vita continua e può riservare anche tante belle sorprese e
gioie come vorrebbe per noi chi ci ha voluto bene e ci guarda dal cielo.
Cesare Borgia e Machiavelli
Grandi italiani o antenati “scomodi”?

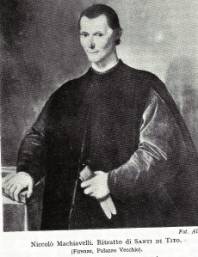
Cesare Borgia (di Papini:Ritornare a Machiavelli)
Il segretario e il suo doppio
(Niccolò
Machiavelli & Cesare Borgia)
di Claudio Papini
E’ libro complesso come
complesso è il periodo storico che tratta, pur in una manciata d’anni dal 1492
al 1513 circa. Ma, come con una macchina del tempo, l’autore si sposta alla
ricerca delle radici dei nostri mali “fin dall’antichità classica del
sovversivismo giudaico-cristiano in funzione antimperiale” (esplicitato nella
contrapposizione Gerusalemme/Roma) fino ai tempi della Riforma luterana. Ne
nasce un grande affresco storico in cui l’indagine si concentra, in quattro
capitoli con sempre nuovi arricchimenti, sulla vita di Alessandro VI (Rodrigo
Borgia) e del figlio Cesare, nominato da lui cardinale a 18 anni.
Alessandro VI, Papa dal
1492 della scoperta del nuovo mondo da parte di Cristoforo Colombo, morì per
veleno nel 1503. Già nipote di Papa Callisto III, era spagnolo, di cognome
Borja, perciò detto dagli italiani Borgia.
Cesare, divenuto Duca di
Romagna, soprannominato il Valentino da quando Luigi XII re di Francia lo aveva
investito della contea di Valentinois,
morì nel 1507.
Papa Alessandro VI era
amante del lusso e del denaro, pensò ad accrescere il patrimonio della Chiesa
in tutti i modi inclusa la simonia (quella dell’acquisto superata da quella
delle vendite), ebbe molti figli cosa che nel costume dell’epoca non
scandalizzava. Tra questi Lucrezia,
usata come “pregevole dono” a fini matrimoniali (per utilità di scambio), ma
apprezzata dal padre che in un periodo di requie, tra un matrimonio e l’altro,
la nominò “governatore” di Spoleto. La “leggenda nera” intorno ai Borgia,
include Lucrezia, oggi riabilitata e che non avvelenò nessuno, ma in parte è
una fake news del passato, costruita da avversari politici. Restano
indubitabili i molti avvelenamenti perpetrati da Alessandro VI e soprattutto da
Cesare. Alla nota 145 (sono 233 le note del libro con precisazioni molto
interessanti) vi è una spiegazione del veleno usato, forse polvere di cantaride
ottenuta dall’essiccazione di piccoli scarabei: a piccole dosi dava effetto
afrodisiaco, con più alte provocava lesioni interne che portavano a morte.
I personaggi di quel
difficile tempo storico appaiono in chiaroscuro come in una saga o moderna soap
Tv. Non a caso il primo atto di Alessandro VI Papa è grande: ristabilì la
pubblica sicurezza e fece pagare gli stipendi. Da politico comprese che solo
con la forza poteva ripristinare lo
Stato pontificio come prima dell’invasione del 1494 da parte di Carlo VIII di
Francia e con Cesare compì un’opera di riorganizzazione e ristrutturazione con
il fine di supremazia in Italia. Gli viene attribuita l’espressione “che il
sovrano francese l’aveva conquistata con il gesso” perché gli bastava segnare
sulla carta topografica una città italiana col gesso e questa senza opporsi gli
apriva le porte.
In un panorama di
staterelli italiani, dove Venezia era l’unica degna del nome di Stato, nasce la
“fascinazione” di Machiavelli (difensore della libertà di Firenze, la sua
città, di cui era segretario) per Cesare: “perché l’animo del guerriero era
grande e l’intenzione alta”, perché nonostante la condotta criminale e lasciva
“era uomo all’altezza dei propri sogni o per lo meno si sforza di esserlo”.
Soprattutto perché “o Cesare o nessuno sarebbe stato capace di annientare il
Papato, causa di tutti gli interventi e fonte di tutte le divisioni d’Italia”.
Solo la militarizzazione dello Stato pontificio poteva attuare una
laicizzazione dello Stato e la supremazia in Italia.
La militarizzazione
avvenne grazie alle virtù da soldato di Cesare. Una dimostrazione della sua
forza intrepida è in un episodio: quando in piazza S. Pietro, in uno spazio
chiuso davanti ad una Basilica diversa dall’attuale, atterrò in stile corrida
sei tori selvaggi.
Non solo quando morì Papa
Alessandro, Cesare che era stato anche lui avvelenato sopravvisse, ma malato e
lasciato tra due potentissimi eserciti nemici, ebbe una Romagna (il suo ducato)
così fedele che lo aspettò per un mese. Non solo, quando Machiavelli va a
trovare Cesare, ormai in prigione, lo trova circondato da fedelissimi amici.
Scrive Papini: “Non
dovevano dispiacere la risolutezza di
Cesare nell’attuazione delle decisioni e la sua opportunistica ferocia di
hidalgo a Machiavelli che da giovane a Firenze non aveva sopportato il
temperamento dei Piagnoni e nemmeno l’arroganza degli Arrabbiati”.
Per il fiorentino Cesare
fu Il Principe (libro scritto
nell’esilio di S. Canziano nel 1513, qualche anno dopo la sua morte e
meditatamente non per impulso di eventi esterni).
Quanto alla parte nera
del Valentino, numerosi gli assassini tra cui anche quello del fratello minore,
duca Juan di Gandía, prediletto dal padre. Papini per queste “pulsioni” come le definisce, accosta Cesare a Gilles
de Rais compagno d’armi di Giovanna D’Arco, che nella guerra dei Cent’Anni le
dimostrò “ben oltre la partecipazione alle operazioni militari” dimostrando la
sua patologia.
Al Cesare politico,
Machiavelli per cui la politica, è
“arte del possibile realisticamente intesa”, imputa un solo errore: essersi
fidato di Papa Giulio II appoggiandone l’elezione. Giuliano della Rovere, nato
ad Albisola di Savona, sotto lo scandaloso pontificato di Alessandro VI era
stato per 10 anni esule da Roma. Da Papa promise al Valentino, già colpito da
sorte avversa e rifugiatosi in Castel Sant’Angelo a Roma quindi (un problema in
più questo per lo Stato pontificio), gli promise che lo avrebbe confermato
“nella carica di gonfaloniere della Chiesa, capitano generale e nel possesso dei suoi Stati”. Invece compí
“una rete sottile” affinché i domini del Valentino tornassero al controllo della Chiesa, abrogò il Ducato di
Romagna come realtà politica e territoriale indipendente, fece imprigionare
Cesare.
Per le luci ed ombre di
tutti questi comprimari-protagonisti del libro Giulio II fu grande mecenate di
Bramante, Raffaello, Michelangelo e fece leggi giuste. Tra le tante abolí i
duelli e lo ius naufragii, cioè il diritto di spogliare i naufraghi (e quel
barbaro diritto nell’Italia d’oggi, buonista ma anche affarista con le
cooperative, si è trasformato in accoglienza “senza se o ma” dei migranti da
non lasciar naufragare).
Dall’antico,
proiettandosi nei problemi moderni, Papini non manca di stigmatizzare l’Italia
dei differenti governi nazionali, “in
particolare quelli ispirati da ideologie internazionaliste, dunque
cristiano-cattoliche e tardo social-marxiste”, che ha portato da noi circa
6 milioni tra immigrati “comunitari” ed “extracomunitari”.
Il pregio del libro è
ripercorre con chiara analisi critica quegli anni di un’Italia ancora in fieri,
così travagliati tra nemici e alleanze con re stranieri che facevano a gara per
accaparrarsi “il nostro giardino”, ma soprattutto è risalire alle radici
lontane dei nostri mali.
Papini è cultore di Daniel Massé, di cui ha ospitato diversi
libri nella Collana “Amici del Libero Pensiero” (www.amiciliberopensiero.it)
che dirige per De Ferrari, l’Editore genovese con cui ha anche pubblicato
questo suo. Nel 2012 ha scritto su Daniel Massé e gli enigmi del cristianesimo
e in sintonia con lui risale allo scontro antico tra Roma e Gerusalemme, al conflitto di Gerusalemme con diversi centri
politico-religiosi di lingua araba, quindi tout court al conflitto Oriente/Occidente. Osserva
Papini che ai giorni nostri Italia e Israele sono due stati che fanno parte
dell’Occidente a tutti gli effetti, però penso quanto sia tuttora “diffidente”
la nostra Europa verso la realtà storica d’Israele e molto più propensa a
capire i palestinesi specie dopo la decisione di Trump, giunta dopo la
pubblicazione del libro, di decretarne Gerusalemme capitale.
Per la lunga Storia,
narrata nel libro, è da ricordare che il 1498 (nel pieno del Pontificato di
Alessandro VI) è anche l’anno in cui Gerolamo Savonarola, il “profeta
disarmato” che di Firenze voleva fare la nuova Gerusalemme, è condannato al
rogo. Quel titolo sarà da attribuire a Ginevra, ad opera di Calvino (però dopo
il 1536 precisa l’autore). Ma esso risale al 1517 della nascita e diffondersi
della Riforma, figlia d’Umanesimo-Rinascimento. Proprio la reazione a quel nostro
importantissimo periodo storico, con il conseguente desiderio di restaurare una
nuova Gerusalemme, è stato anche frutto dell’opera di Gerolamo Savonarola.
Di qui un nuovo ed
assoluto bisogno di studiare la Storia.
Da questo libro, che offre il piacere dell’intelligenza,
si può pensare a voler ricreare per il nostro futuro, pur se il tempo sembra
breve, una parola potente come Ri-nascimento (nuova nascita) o Ri-sorgimento
(nuova resurrezione).
UN'ANALISI DEL LIBRO DEL
PROF. GIULIO VIGNOLI
SULLE ORIGINI E LA STORIA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
 Repubblica Italiana – Dai brogli
e dal Colpo di Stato del 1946 ai giorni nostri è un libro-bomba lanciato sulla
Repubblica Italiana. Per disseppellire le menzogne che hanno accompagnato
la nascita della RI come la chiama tout court l’autore Giulio Vignoli. Solo RI,
in quanto non meritevole di altro nome perché nel dopoguerra “il regime
politico s’impadronì del potere senza mandato popolare”.
Repubblica Italiana – Dai brogli
e dal Colpo di Stato del 1946 ai giorni nostri è un libro-bomba lanciato sulla
Repubblica Italiana. Per disseppellire le menzogne che hanno accompagnato
la nascita della RI come la chiama tout court l’autore Giulio Vignoli. Solo RI,
in quanto non meritevole di altro nome perché nel dopoguerra “il regime
politico s’impadronì del potere senza mandato popolare”.
I fatti: il
Referendum del 2/3 giugno 1946 si svolse con i voti per la Corona e la
Monarchia nettamente in testa fino a tutto il 4 giugno. Una valanga di voti
repubblicani sarebbe arrivata nella notte fra il 4 e 5 giugno, proveniente dal
Sud, cosa non credibile giacché il Sud votò in massa per la Monarchia.
Importante: dal Referendum erano stati esclusi Alto Adige, Venezia Giulia con
Gorizia Trieste Pola Fiume le isole del Quarnaro, Zara perché in discussione la
loro appartenenza all’Italia. Per Zara, quando Ciampi nel 2001 le attribuì la
medaglia d’oro in quanto città martire, ci fu l’insurrezione del presidente
della Croazia per cui risulta tuttora congelata. E a quei profughi
dell’esodo a suo tempo De Gasperi fece prendere le impronte digitali.
Dal 13 al 18 giugno il potere in Italia fu detenuto dall’Alcide e “Soci di
fatto, ma non di diritto”, con interruzione della continuità costituzionale.
Umberto II, pronto ad inchinarsi alla volontà del popolo, aveva affermato di
voler attendere il 18 giugno per la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione
su “reclami, numero votanti e voti nulli”. Agli Italiani scrisse il 13 giugno:
“Improvvisamente, questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente
e sovrano della Magistratura, il Governo ha compiuto un gesto rivoluzionario,
assumendo con atto unilaterale e arbitrario poteri che non gli spettano”.
La Presidenza del Consiglio (De Gasperi) rispose con un comunicato vergognoso
su “falsi”, mentre avrebbe dovuto baciargli i piedi poiché toglieva l’incomodo.
Il Re, se avesse voluto reagire ai brogli e al Colpo di Stato, avrebbe avuto
ottime possibilità di vittoria come dimostrato nel libro dalle forze elencate e
a sua disposizione.
“Era l’inizio dell’odio dei vermi”, scrive Vignoli, repubblicano di sentimenti
ma che giovanissimo iniziò a prendere le difese della Monarchia sabauda e dei
monarchici in quanto perseguitati e osteggiati, cosa che gli procurò
discriminazioni nell’ambiente di lavoro. L’amor di Patria del professore, già
docente universitario a Giurisprudenza e a Scienze Politiche per quasi 50 anni,
risalta nella sua vita: ha cercato le minoranze italiane disperse in Europa, ne
ha scritto (centinaia di pubblicazioni: libri saggi articoli).
L’impietoso confronto!
1) Il giorno dell’abdicazione Vittorio Emanuele III donò allo Stato italiano la
sua famosa collezione di monete, la più grande al mondo, valutata miliardi;
Umberto II per le spese del Referendum impegnò la famosa collana di perle
della Regina Margherita e prima di partire -con due sole valigie-
consegnò alla Banca d’Italia i gioielli della Corona.
Il PCI, fino all’epoca di Gorbaciov, fu finanziato dall’URSS con un enorme
flusso di denaro, diventando potenza economica con enorme patrimonio
immobiliare, pseudo cooperative, banche come MPS. Ebbe le tangenti del
commercio Italia-URSS e a tutto questo presiedette per anni Giorgio Napolitano
come attestato dalla deposizione di Craxi al Tribunale di Milano nel processo
per “Mani pulite”.
2) Il PCI fu sempre ladrone: dall’oro di Dongo (denaro della Banca d’Italia e
quindi degli Italiani) financo ai diritti miliardari d’autore dei Quaderni di
Gramsci. Mentre alla di lui figlia, bambina che viveva in Russia, portavano in
dono solo una bambolina.
All’inizio ho parlato di una bomba lanciata e questa ha scoperchiato un
vaso di Pandora. Al fondo l’idra feroce del PCI, ma prima, in superficie, tanti
mostriciattoli artefici del Comunismo. Napolitano certo, ma anche Togliatti, il
criminale astuto (vedi Hotel Lux e periodo della guerra civile spagnola), Nenni
che ebbe il “Premio per la Pace Stalin”, prima che se ne svelassero i crimini,
De Gasperi definito da Vignoli “viscido austriacante”.
Pregio di
questo libro è non fermarsi al passato ma arrivare con cruda e documentatissima
analisi ai giorni nostri: dal ’68 alle Br.r., a Berlusconi e alla mala
giustizia cioè quella politicizzata, alla scuola dei tutti promossi, alla
mafia, ai processi che videro condannato Priebke che obbedì ad ordini
superiori e assolto Piskulic, assassino dei nostri fratelli fiumani, all’odierna
invasione musulmana. Il lettore troverà irriverenti, ma azzeccate definizioni,
anche per Obama e Papa Bergoglio.
A questo
punto conta molto ricordare i nomi. A partire dalle due pagine (18/19) in cui
sono elencati molti di coloro che al Referendum votarono Monarchia: “le più
alte intelligenze italiane dello scibile in tutti i campi”. Nell’elenco ne cito
alcuni perché molto conosciuti: Gino Bartali, Mariù Pascoli (sorella del
poeta), Alberto Sordi, Raf Vallone, Amedeo Nazari, Macario, il cardinale
Idelfonso Schuster, Valentino Bompiani, Giorgio De Chirico, don Carlo Gnocchi
fondatore dell’Opera Mutilatini (Umberto II ospitò al Quirinale i mutilatini
della guerra perduta), Leo Longanesi, Indro Montanelli, Padre Pio di
Pietralcina che profetizzò “Un ramo seccherà (Savoia-Carignano), un ramo
fiorirà (Savoia-Aosta)…
E “martiri” sono usciti dal vaso di Pandora.
Gli
antichi come i nove giovani di via Medina definiti da Napolitano: “popolino
monarchico isterizzato”. Il 12 giugno, dopo il referendum, in una Napoli quasi
tutta monarchica, alla sede del PCI in via Medina espongono una bandiera senza
stemma sabaudo. Chi cerca di arrampicarsi per toglierla viene ucciso a raffiche
di mitra. Ida Cavalieri, una studentessa, ebrea milanese, avvolta nella
bandiera del Regno muove alla testa di un centinaio di studenti per fermare le
camionette della polizia ma, travolta da queste, muore all’ospedale. Commenta
Vignoli: “a Tienanmen il carrista deviò per non travolgere lo studente.
Migliori i comunisti cinesi di quelli nostrani?” Vennero anche uccisi dai
comunisti due Reali Carabinieri di cui non si svelò mai l’identità come scritto
nel libro Umberto II e la crisi di Giovanni Artieri.
Pregio grande del Vignoli è citare una messe di libri storici
controcorrente: altri, in questa nostra Italia dell’occultamento, hanno avuto
il coraggio della verità.
Come sigla di Vignoli si potrebbero assumere queste sue parole: “La Sinistra
non dimentica, anch’io non dimentico e non perdono”.
Ad un martire, più recente, è dedicato il libro: al Caporale degli Alpini
Matteo Miotto, che il 31 dicembre 2010 morì in Afghanistan, paese dilaniato da
Talebani e ora anche da Isis. Morì dopo aver sventolato dal carro armato la
Bandiera Italiana con la Croce Sabauda. Il Comando nella foto che diffuse
censurò lo stemma. Intervenne il padre di Matteo a mostrare la vera
immagine.
Il 10/11 aprile 2016 la tomba di Miotto è stata vandalizzata e torno
all’immagine della bomba lanciata. “Il fine giustifica i mezzi” è nota frase
che Machiavelli mai scrisse. Se il fine della RI doveva essere “gettarsi alle
spalle il passato per costruire la pace”, il non aver mai fatto i conti con il
vero passato ha inquinato il risultato. Dal vaso di Pandora scoperchiato
è uscita una nube di Chernobyl che con l’ignoranza ancor oggi ottunde le
coscienze.
Giulio Vignoli
Repubblica Italiana. Dai brogli e dal Colpo di Stato del 1946 ai giorni nostri
Settimo Sigillo-Europa Lib. Ed, 2017
Pagg: 176 Euro 15,00
ISBN: 9788861481916
Ho riportato la
mia recensione come è stata pubblicata su www.monarchia.it
il giorno 29 gennaio 2018
In copertina
del libro la foto di Mario Fioretti, anni 24, uno dei nove giovani uccisi in
via Medina a Napoli l’8 giugno 1946 (v. pp.38/39 del libro)
Dal
libro di Vignoli aggiungo alcune foto



E ora aggiungo, da un libro che chiesi a
mio padre come regalo per la maturità e avendo avuto un ottimo risultato mi
accontentò,
le
firme di Umberto II e di Maria Gabriella.
Nella
pagina, a matita e con la mia scrittura gallinesca, la data del mio
articolo per Il Giorno – Cultura
quando Gabriella venne a Palazzo Ducale di Genova per l’inaugurazione della
mostra dell’antenato Odone: 21/12/1996
Storia della Casa di Savoia
in due volumi e in 400 copie autografate da Umberto II è stato a cura di
Fernand Hayward per Cappelli Editore, la mia copia è il n.54.
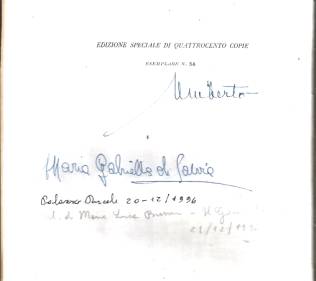
Ricordo solo a proposito della firma di
Maria Gabriella messa sotto a quella di suo padre Umberto, che prima studiai la
principessa e poi, avendo ammirato la sua grazia e compostezza, le porsi il
libro chiedendo di autografarmelo.
Lei, quando vide la firma del padre, si
commosse.
La prima volta che votai, sposa a 21 anni
mentre frequentavo il III anno di Lettere Classiche all’Università di Genova (e
mi laureai a giugno del IV con 110 lode e medaglia d’argento) mentre ci
recavamo al seggio con mio marito,
rimasti senza benzina, mi toccò spingere l’auto (per fortuna con l’aiuto
di qualche volenteroso) fino ad un distributore non lontano.
Votai monarchico ritenendo che noi
italiani avessimo un debito con Casa Savoia che fece la nostra Unità. Vedo che
tuttora permangono tanti livori e tante dimenticanze al riguardo. Penso che
mentre stimiamo come statista Alcide De Gasperi, che però -obtorto collo- fu
costretto a lasciare l’Istria alla Yugoslavia continuiamo a scagliarci contro
Re Vittorio Emanuele III considerato quasi traditore d’Italia.
Il libro di Vignoli chiarisce molte cose
incluso il fatto che il Re, in quanto la Corona era povera, fu aiutato nella
fuga dal Papa. In regimi cambiati alcuni sovrani sono stati riaccolti in
patria, noi siamo incapaci di perdono.
Poi tornando a quella prima votazione
votai liberale e mi piace citare queste parole: “Quelli che è sempre colpa del
liberalismo, anche se in Italia neppure esiste. A sinistra (ma pure a destra) è
diffusa l’idea che ogni male della società sia frutto dell’avidità e
dell’arrivismo capitalistico”. Quindi votai DC (come tutte le beghine d’Italia,
commento di mio padre) e poi FI e quando questa cambiò nome pensai che prima o
poi sarei fuoruscita dall’arco parlamentare…
Torno su Maria Gabriella di cui avevo
ammirato la compostezza. Per far capire vi chiedo di confrontare la Regina
Elisabetta e la sguaiataggine di Hillary Clinton nella sua recente campagna
elettorale, quando –sicura delle vittoria- lasciava cadere la mandibola quasi
sul seno ridendo a piena bocca in modo volgarissimo.
Più che le influenze russe (pallino
americano) è stata questa sua volgarità a farla perdere. Per lei non potevano
che partecipare altrettanto volgari starlet americane o campioni dello sport
che hanno tanti soldi ma tanta ingnoranza.
Ricordo che a Palazzo Ducale inviata a
scrivere l’articolo sul Giorno c’era
un’altra giornalista giovane, non ne rammento il nome, ma il sussiego con tanto
implicito disprezzo con cui si accingeva a scrivere dei Savoia: evidentemente
anche lei poco aveva studiato di Storia. Era della categoria di quelli sempre con
il sopracciglio inarcato…
Inserisco ora un’immagine di Gabriella
giovane che io ragazzina avevo ritagliato e che ho conservato nel libro sulla
Storia di Casa Savoia. Cito anche da un
librino Umberto di Savoia comandante del
Gruppo delle Armate dell’Ovest (1940-XVIII) (Estratto dalla Rassegna Italiana –
anno XXIII – Agosto-Settembre 1940 XVIII) che mi fu donato da Luigi
Casartelli, un amico bobbiese (che non è più) e il cui padre era stato uomo di
fiducia del Marchese Malaspina: (p.10) “Il sentimento del soldato lo sospinge
irresistibilmente verso il campo di battaglia dove c’è pericolo, dove si soffre
e si muore…Egli non sa resistere al richiamo, e per tutto il tempo che infuria
la battaglia, corre, appena può laddove più grande è il rischio e più violenta
la lotta. Quanto più il pericolo superato è stato palese e vicino, tanto più il
suo volto appare raggiante”. E nel momento il suo Gruppo Armate si scioglieva,
Umberto disse: (p. 12) “Dieci mesi di vita in comune, di fervida e appassionata
collaborazione, avevano fatto delle nostre volontà una volontà sola…”
Retorica del tempo? Ma penso all’oggi
quando essere insieme non riesce a definirsi in questo modo epico perché non
c’è più sentimento di Patria comune.


Maria Gabriella di Savoia XVII
sec. Trombettieri con drappelle di Savoia
Forse ho sempre avuto una passione per
l’epica e gli eroi:
Achille, il personaggio che più amai
studiando Omero e in cui identificai la ribellione di ogni giovinezza. Lo
studiai per la mia tesi di laurea Aristeia omerica e virgiliana con Enrico
Turolla, dove nel frontespizio di essa il professore scrisse: “L’indagine su
quella che la candidata chiama ‘aristeia egemonica’ (p.182) è realmente e senza
esagerazione rivelatrice anche per chi conosce e ama Omero per avervi dedicato
l’intera esistenza”.
Che belle parole ma coincidono con lo
spirito del giornalismo e dello scrivere in coscienza e verità: “Capire, far
capire e anche farsi capire”.
Aggiungo che ho sempre amato gli eroi:
Achille certo, ma anche Leonida e i 300 alle Termopili, Orlando che a
Roncisvalle suona l’olifante, Camilla di Virgilio che pur se guerriera da donna
si volta a guardare una spilla d’oro ed è trapassata a morte da una freccia,
Giovanna D’Arco che all’offerta di un bianco destriero, disse: “Solo i felici
cavalcano cavalli bianchi e lei aveva già in sé il presagio della disfatta”,
Corradino di Svevia (perché nulla più di una morte giovane è lutto per
l’umanità): “Era biondo, era bello era beato sotto l’arco di un tempio è sepolto…”
E anche eroi ed eroine delle leggende come da quelle delle Dolomiti, raccolte
da Wolff e pubblicate da Cappelli (lo stesso editore della Storia della Casa di
Savoia- grande Editore per averci consegnato queste memorie) Dolasilla, regina
dei Fanes (le marmotte) che non doveva scendere in battaglia se la sua corazza
da argentea fosse diventata scura e invece lo fece morendo per il suo popolo o
come la Delibana, non donna guerriera ma fanciulla che aspetta rinchiusa in una
grotta un amore che non verrà mai più…
Inserisco ora la foto in costume ma è una
foto per turisti e non un costume di Carnevale che ho sempre considerato la
festa più triste dell’anno in un viaggio a Windsor con mio marito, quando il
nostro secondogenito Cesare, appena laureato in ingegneria elettrotecnica
cercando su internet si era trovato un lavoro in una Ditta Inglese e noi per
sette anni (il tempo della sua permanenza per lavoro in Inghilterra) una volta
l’anno andavamo a trovarlo.
E’ una foto per turisti però il
fotografo, un piccoletto grassottello, m’insegnò qualcosa che non ho
dimenticato. Mi faceva vedere come dovevo tenere il ventaglio e soprattutto non
voleva ridessi in quanto le dame inglesi (ma era la stessa tradizione per le
nobildonne genovesi) dovevano o stare serie o sorridere come se avessero un
acino d’uva stretto tra le labbra.
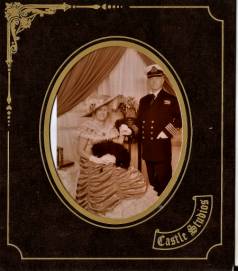
Maria Luisa e Giovanni a Windsor (in costume)
E poiché sono un’archivista anche se
molto disordinata, avendo citato la mia tesi, allego un ricordo del prof.
Enrico Turolla che mi avrebbe proposto per il diritto di pubblicazione se mi fossi fermata all’Università
accettando di migliorare qualche capitolo.
Il Professore voleva restassi per
offrirmi la possibilità di continuare in ambito universitario, ma l’Università
di allora mi sembrava vecchia e polverosa.
Quando avevo detto a Turolla, al terzo
anno d’Università, che mi sposavo, aveva commentato: “Povera bambina” e dopo mi
aveva chiesto scusa spigandomi che aveva pensato ai sacrifici di sua cognata
rimasta presto vedova.
Il pensiero di Turolla coincise con
quello di Gina De Benedetti mia amata professoressa del ginnasio: “Tante belle
intelligenze femminili vanno sprecate” . Però resto orgogliosa di 30 anni da
giornalista pubblicista, sempre con 4 o 5 articoli la settimana e collaborando
in contemporanea ad almeno due giornali. Sono orgogliosa anche delle due Scuole
Superiori (comunicazioni sociali, giornalismo) in cui mi diplomai
all’Università Cattolica sempre con il principio del presto e bene: massimo dei
voti nel minor tempo possibile.
Era stato proprio Turolla a chiedermi di
fare la tesi con lui. Gi avevo detto che desideravo laurearmi in lingua e
letteratura italiana e la sua risposta era stata: “Perché quando la letteratura
greca è tanto più originale e profonda?” Mi convinse e ora so che aveva ragione
in questo giudizio: il patrimonio di idee, la saggezza, l’indagine storica che
fanno di Erodoto anche un cronista dell’antichità, l’incredibile leggerezza dei
poeti dell’Antologia Palatina restano in chi li ha studiati. Sono una ricchezza
dello spirito.
Ancora un episodio da quegli anni giovani: ricordo che Turolla
dopo l’esame di bizantino che si dava al quarto anno mi disse: “Non ti do la
lode perché al corso siete tutte donne e se no la vogliono anche le altre”. E
aggiunse: “La tua tesi così bella l’hai fatta proprio tu?”. Piangevo, fuori
dall’aula, per quel commento. Passò un ragazzo e mi batté la mano sulla spalla:
“I professori sono tutti pazzi, cosa ti ha dato?” E io tra le lacrime:
“Trenta”. Lui batté i tacchi, mi fece il saluto militare inabissandosi al fondo
del corridoio. Tra le lacrime io piangevo e ridevo.
Articolo di Mario Messina
Rubrica Musica
Gazzettino di Venezia
11 gennaio 1985
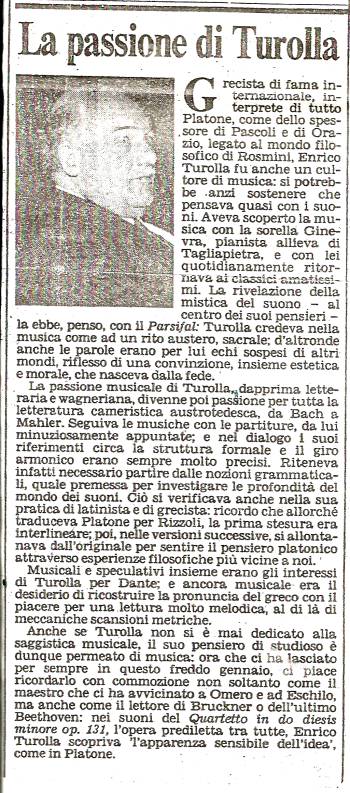
Le storie più brutte
di Emilio e Maria Antonietta Biagini
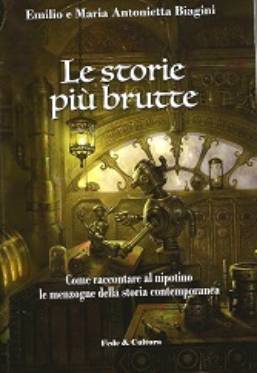
Le storie più
brutte - Come raccontare al nipotino le menzogne della storia contemporanea
per Fede & Cultura è la più recente opera di una coppia di scrittori:
Emilio e Maria Antonietta Biagini. Lui, docente universitario e fecondo
scrittore, Lei che ha studiato a Genova già autrice di diverse pubblicazioni.
Loro notizie sul su www.itrigotti.it.
Questo nuovo libro è illuminante, di chiarezza e
semplicità di scrittura quindi più che adatto alla divulgazione, ma anche denso
e arduo per la storia controcorrente rispetto a ciò che imparammo a scuola e che i ragazzi tuttora
imparano.
I due autori sono profondamente religiosi e per i mali
della nostra contemporaneità partono da alcuni momenti fondamentali: la Riforma
protestante, la Rivoluzione francese, la Massoneria.
La Riforma, figlia di un Rinascimento che affermava
l’uomo come centro dell’Universo, aveva favorito la ribellione protestante
contro la Chiesa e il pensiero di un
successo mondano capace di aprire le porte del Paradiso. Fu il primo assalto
alla Chiesa tradizionale.
Come gli autori spiegano nell’“Antico Regime molte
delle migliori tradizioni cristiane come ordine, nobiltà d’animo, serenità di
spirito, si conservavano presso la maggior parte delle famiglie”. Ma “la
Rivoluzione insegnò a vivere secondo l’interesse personale, all’insegna del
denaro e dell’avidità, distruggendo quanto era di buono nell’Antico Regime”.
Nel libro una delle parti più interessanti riguarda
proprio quella Rivoluzione di “Egalité. Liberté. Fraternité.” che i meno
ortodossi alla vulgata corrente hanno sempre interpretato sottolineando il
“punto”, cioè “point” (= niente) di tutte queste cose.
Dal libro una considerazione, importante e inusuale:
alcuni storici si sono basati sulle lamentele dei contadini francesi che per
sfuggire ad una tassa sui redditi, detta “taglia” e applicata in base alla
ricchezza visibile, ostentavano una povertà che non c’era. Il popolo prima
della Rivoluzione francese non era in miseria o in quella miseria che li spinse
a prendere la Bastiglia al grido di “pane, pane!”.
Su questa conquista dei rivoluzionari il libro fornisce
dati: i rivoltosi erano al massimo 6000 su un totale di 20 milioni di francesi,
il 14 luglio 600 ammutinati rubarono fucili e munizioni. La propaganda
massonica poi dipinse la fortezza come un’orrenda prigione mentre allora
c’erano solo 7 prigionieri e la guarnigione era composta da poche decine di
uomini per lo più invalidi.
Non solo, l’intera Parigi assisteva al ridicolo
assedio, qualcuno fin con cannocchiali. La banalità dell’accaduto è
testimoniata perfino da un estremista rivoluzionario come Marat. Tra i delitti
della Rivoluzione l’aver inventato il “genocidio”, quello dei vandeani.
Molto dissacrante nel libro la rivisitazione di
personaggi illustri: Napoleone, Garibaldi, Mazzini, Cavour, Pellico…
Gli autori definiscono Napoleone “individuo odioso che
devastò e saccheggiò l’Europa e rubò tutti i capolavori d’arte su cui mise le
mani”. Se però a Napoleone bisogna riconoscere quella marcia in più che hanno
solo alcuni, per Mazzini troviamo queste parole: “un distruttore capace solo di
architettare cospirazioni e di mandare a morire i suoi seguaci compiendo
attentati e atti terroristici da cui lui si teneva a debita distanza”. E il
capitolo che riguarda Cavour porta il titolo: “Gli intrighi di Cavour”.
Garibaldi? Ci viene presentato nel capitolo che riguarda la fuga di Pio IX, da Roma a Gaeta,
all’inizio della Prima Guerra d’Indipendenza (1848/49): “arrivò Garibaldi, già
attivo in Sud America come ladro di cavalli e commerciante di schiavi cinesi
destinati a morire nelle terribili miniere di guano”. Viene anche denunciato
l’apporto di bande mafiose alle schiere garibaldine per conquistare il Regno di
Napoli. Cosa che avvenne più con la corruzione di alti ufficiali dell’esercito
e della marina del Regno stesso e con l’appoggio della malavita del
Mezzogiorno.
Mentre le bande garibaldine devastavano il Sud,
l’esercito sabaudo invase senza dichiarazione di guerra e senza giustificazione
lo Stato pontificio, lasciando al Papa solo il Lazio. Per di più nella ricerca
di denaro per finanziare le guerre il governo post-unitario aggiunse alle tasse
anche quella sulle porte e finestre che subito furono costruite più piccole,
con poco spazio al sole e incremento della TBC.
Il libro affascina proprio per queste minute notizie
che riguardano la vita quotidiana dei tanti, ma porta anche giudizi critici
molto severi, disfacendo pregiudizi: “non è vero che lo Stato Pontificio e il
Regno delle Due Sicilie fossero sacche di arretratezza”. Un esempio. La Roma di
Pio IX aveva un ospedale ogni 9000 abitanti ed un istituto di beneficenza ogni
2700 abitanti. Londra, centro del maggior Impero mai apparso sulla terra, aveva
un ospedale ogni 40mila e un istituto di beneficenza ogni 7000. Fin dal
Seicento il governo di Londra era stato
inventore e precursore del lager della Germania nazista e del gulag dell’Unione
Sovietica: gli indesiderabili erano imprigionati nelle colonie britanniche.
Silvio Pellico, venuto ventenne da Saluzzo a Milano a
cercar fortuna, ebbe successo ma dovette entrare nella Massoneria. Si affiliò
alla Carboneria, arrestato nel 1820
ricevette la condanna a morte per alto tradimento, ma dopo 8 anni fu
graziato e liberato. Nel suo Le mie
prigioni, scritto in carcere, si dichiarò desideroso di tornare alla
religione cattolica e affermò che gli austriaci non erano per niente malvagi
come da propaganda massonica. Osservazione dei Biagini: “oggi nelle antologie
scolastiche di Pellico si ricordano solo i brani esaltati un tempo dalla
propaganda massonica per distogliere l’attenzione dal resto del libro”.
Pellico fu autore anche de I doveri degli uomini in cui, da galantuomo e da cattolico, parla
di doveri mentre “tanti mascalzoni – osservazione dei Biagini per il nipotino –
parlano solo di diritti”.
Non a caso, il prossimo libro che i Biagini hanno in
mente riguarderà l’Austria, anch’essa colpita da una propaganda non veritiera
ai tempi del nostro Risorgimento.
Quanto alla Massoneria, tanto spesso accusata nel
libro, la spiegazione nel volume VIII del Grande Dizionario Enciclopedico della
Utet è: “Associazione segreta a carattere speculativo e scopi genericamente
filantropici, sorta nel XVIII secolo in Inghilterra sulla base di precedenti
filoni e tradizioni sia esoteriche, sia operative. In Italia contribuì al
Risorgimento (affiliati Mazzini, Cavour,
Garibaldi). Il Fascismo provvide al saccheggio sistematico delle sue
sedi. Ricomparve di pari passo con la Liberazione, riportando nel 1944 a Roma
il Supremo Consiglio d’Italia.
Da queste notizie tratte dal Dizionario penso che ebbe
fortuna e peso come tutte le Associazioni di potere con adepti importanti, ma
confesso la mia ignoranza al riguardo.
Quanto all’Austria, nata a Trieste, so che quando
moriva un funzionario asburgico, la prima pensione - con le giuste parole di
condoglianza- veniva portata alla vedova da un inviato da parte
dell’Imperatore.
Mia
indissolubile compagna
Lettere a Laura Boschian di Salvatore Satta
(Interessante notare - e ho segnato in
rosso - le frasi dell’insigne giurista e scrittore sardo che ci riportano ai
momenti della nascita della nostra Repubblica e appaiono coincidenti per
atmosfera con quanto detto nella recensione precedente dal prof. Giulio
Vignoli).
Anticipo una foto del matrimonio di Salvatore e
Laura, 3 maggio 1939, davanti alla cattedrale di Trieste tratta da Padrigali mattutini, sempre del
giurista, che allegherò di seguito, avendo avuto la fortuna di leggere anche
quel delizioso libro).

Mia indissolubile compagna – Lettere a Laura
Boschian 1938-1971,
con titolo tratto da una
lettera, prosegue da parte della
sarda Ilisso nella riproposta del giurista Salvatore Satta. Questi come
scrittore è rimasto nella memoria
soprattutto per Il Giorno del giudizio
(edito postumo nel 1971), grande libro etico del ‘900.
Nel 2015, per Ilisso,
ottima casa editrice (testi eleganti, raffinate copertine e carta delle pagine
che fa venir voglia di annusare i libri), è uscito il delizioso Padrigali mattutini, a raccogliere quei
pensieri che il giurista, prima di recarsi al lavoro, lasciava alla moglie.
Questo nuovo volumetto ci propone 119 lettere, da lui indirizzate a Laura, di
cui un’ottantina dal dicembre 1938 all’aprile 1939, poco prima del loro matrimonio celebrato il 3 maggio 1939.
Accuratissima, illuminante
per contestualizzare le lettere e meglio capire, la prefazione di Angela Guiso.
Risalta innanzi tutto la
storia d’amore tra Satta di 36 anni e la slavista Laura, la triestina
ventiquattrenne, allora assistente volontaria alla cattedra di Letteratura
Russa a Padova. Il giurista sta per lasciare questa Università in cui aveva
insegnato Diritto Processuale Civile per la nuova sede di Genova. Chi non crede
al colpo di fulmine, e reciproco, si ricrederà poiché proprio nel momento del
primo incontro Satta chiede a Laura se sia già fidanzata: potrebbe innamorarsi
di lei e non vuole pasticci. E Laura, a sua volta, precisando che per lei non
contava più nessuno, scrive nei suoi diari: “Ormai avevo preso la coincidenza
per Satta”.
E’ una storia raccontata
in questo documento solo dalla parte di lui e dove lei appare l’approdo. Lui,
pur nella sua saggezza, è percorso da dubbi e tormenti, Lei è la donna forte
che guiderà la famiglia pur se si definisce “donnina” poco preparata alle cure
domestiche. Lui stesso è impreparato al metter su casa, cercarla a Genova,
trovare i mobili. Così, leggendo le lettere, troviamo passi in cui si parla di
paure (con effetti un po’ esilaranti ma teneri, quasi commoventi) di fronte a
questo futuro borghese e casalingo.
Emerge però - a tutto
tondo - la personalità eccezionale dell’uomo di legge. Nel 1968 l’amico Enrico
Biamonti, dopo aver letto i suoi Soliloqui
e colloqui di un giurista, gli scrive: “Dio volesse che la scienza
giuridica fosse veramente una scienza morale, quella che, nei suoi valori, non
dovrebbe mai mutare, pur adattandosi ai tempi”. Satta sente insoddisfazione
verso tale scienza giuridica che dovrebbe cambiare. “Il giurista non vede
l’uomo e continua a studiare la norma”, scrive pensando che l’uomo è proiettato
verso la luna mentre il giurista sembra rigettato in un passato antico, e
ancora: “Processo vuol dire procedere cioè andare avanti, mentre il giudice
parla un linguaggio negativo, una vera e propria lingua morta”.
Le opere giuridiche di
Satta sono state molteplici, importanti proprio nella direzione di uno
svecchiamento necessario, di un adeguarsi a tempi che cambiano. Ho voluto
partire dal giurista perché Satta amò molto il suo lavoro, ma in generale amò
lo studio che apre alla conoscenza. In una lettera del gennaio 1939, a pochi
mesi dal matrimonio, scrive a Laura: “Amo molto lo studio e desidero che anche
Lei lo ami e continui ad amarlo”.
I due sposi prenderanno
l’abitudine di letture serali in comune sui classici italiani, ma anche
stranieri e soprattutto su quegli autori russi che lei faceva conoscere a lui.
A queste letture seguiranno i viaggi di famiglia con i due figli, in Italia e
in mete lontane.
Illuminante questa frase
di Bob (così viene chiamato Satta in famiglia, diminutivo da Bobore o
Boboreddu, in sardo Salvatore): “Bob cammina a testa in giù, a testa in su con
la fantasia che ci rende simili a Dio”. La sua leggerezza deriva dall’euforia
dell’amore e del matrimonio che si avvicina; mentre in un momento di
depressione causato dalla guerra annota: “I pensieri vagano qua e là con un
volo tondo di pipistrello impeciato”. Il suo linguaggio (e altrove ha espresso
che per lui “scrivere belle lettere è un’intima gioia”), ci disvela qualità di grande scrittore.
Della guerra nelle
lettere poche notizie a parte qualcuna sul razionamento dei cibi. Per contrasto
risaltano due sue esternazioni: “Nella giornata festiva che vedrà una grandiosa
adunata di popolo osannante per i nostri immancabili
destini…” (dell’ottobre 1940 e vi si coglie l’ironia); quindi il 14 giugno del 1946: “A Roma sono diventato
fierissimo monarchico, avendo assistito ad una sfilata di repubblicani, redivivi fascisti in camicia rossa, vomitanti ingiurie ed errori di grammatica
dalla libera bocca”.
Quanto alla caratura
dell’uomo risalta un saldo amore di famiglia, per quella d’origine (si occupa
di un nipote che appare demotivato) e quella che si è costruito e sembra voler
racchiudere in un cerchio magico, solo per loro. Quando ai due sposi si aggiungono i due figli, dice del
secondogenito Gino, di cui ha ricevuto una foto del marzo 1944 e non aveva
ancora un anno: “Gino non sorride perché sa che la vita è una cosa seria e una
cosa serissima nella vita è il babbo”.
I figli, già più
grandicelli, che lo vengono a prendere alla stazione, sono definiti: “I soliti
due ceffi di famiglia”.
Un gran bel diario in cui
risaltano anche squisitezze del cibo nella vita domestica come la “barbagliata”
o un dolcetto della Pasticceria Preti. Salvatore, di cui si capisce la gioia
quando abitando in Corso Italia di Genova e leggendosi qualche lettera della
moglie la percorreva tra sole e mare, si lascia anche scappare un giudizio
impietoso di confronto tra città: “Genova dopo l’eleganza di Trieste mi è
sembrata tanto brutta nella sua pompa briosa di palazzi umbertini”.
PADRIGALI MATTUTINI
di SALVATORE SATTA
“Fu chiesto a un’ape
cos’è la vita:.../’La vita è sole, sole, sole’./La domanda fu posta a una radice:...
‘La vita è vento, vento, vento’”. Versi tratti da Padrigali mattutini di Salvatore Satta, un delizioso librino
sapienziale ma con l’incredibile leggerezza dell’essere. Sono le rime che il
giurista lasciava come saluto prima di
uscire per il lavoro alla moglie, Laura Boschian, da lui affettuosamente
chiamata Mucio, e ai due figli Luigi e Filippo che ora li hanno raccolti e
pubblicati con l’Editore Ilisso.
Con questo stesso Editore
sardo uscì Il giorno del giudizio,
uno dei libri più etici del ‘900 che consacrò Satta come grande scrittore
oltreché giurista di fama autore di numerose pubblicazioni tra cui si ricordano
Commentario al codice di procedura civile
e diritto processuale civile (1966) e Soliloqui
di un giurista (1968). Da notare che pure Il giorno del giudizio uscì postumo due anni dopo la morte di
Salvatore nel 1975, alla cui stesura aveva atteso dal 1970 e che fu tradotto in
16 lingue. Satta aveva esordito come scrittore nel 1926 con il romanzo La Veranda in cui raccontava due anni
passati in sanatorio poco più ventenne e allora la tisi era una malattia che
faceva paura dato che era non solo molto contagiosa, anche spesso mortale. La
sua limpida coscienza lo aveva spinto a narrare quella prima esperienza di un
dolore personale e di un primo amore nato in sanatorio per condividerne le
riflessioni con altri.
Le rime mattutine che i
figli hanno voluto raccogliere - e non è stato solo un atto d’amore familiare
anche un dono di ‘predisposizione alla vita’ che fa bene ai tanti per quel
guizzo di bonomia (come si sarebbe detto una volta), quello sguardo sereno sul
nostro esistere con tutta la poesia della quotidianità. Questo pur nelle
difficoltà di ogni giorno che sempre si apre come un’incognita, come una
piccola battaglia da affrontare.
I versi possono essere
molto domestici e riguardano lo sciacquone che si è guastato nel bagno dei
bimbi (e di cui dovrà occuparsi Mucio per farlo riparare) ma anche il Congresso
dei giuristi, quelli delle “inutili parole” (un costume che abbiamo visto
riguardare non solo i Convegni di studio, anche i vari tavoli di concertazione,
le Circoscrizioni e i Municipi, le pubbliche assemblee, il Parlamento di ieri e
di oggi). Condividiamo la sofferenza di Salvatore che va ad un congresso di
quella gente (i giuristi) “che non sa cosa fare tra Jaeger porco e Enrico
Tullio fesso”. Salvatore ci riempie di simpatia nel firmare estroso queste rime
unendo al suo appellativo “Bibi” quello
di Dante, come altrove si chiamerà Bibi Petarca o ancora Iona quasi fosse il
biografo errante. Altre volte, secondo l’estro del momento, si firma Pindaro o
Salvator Dalì e lo fa spesso per ricordare che “il frigorifero piange”, che “il
lavandino è da sturare”, che il papassino (dolcetto sardo per la colazione del
mattino) era “schifoso”, senza però dimenticare un contentino per la moglie che
dovrà assumersi l’incombenza delle
riparazioni: “Non sono né Onorio né Arcadio/ ma sono la tua metà./Trasporta pure l’armadio/ se questa è la tua voluttà”.
L’amore per la moglie
triestina risalta in questi versi con cui la descrive in una riunione di amici:
“col suo passo da cerbiatta/pur se un poco attempatella/ ma per me tuttavia
bella/ viene la Signora Satta”.
Quale sposa dopo tanti
anni di matrimonio non vorrebbe una così dolce dichiarazione, tanto più vera
delle candele accese e dei giganteschi mazzi di fiori di stupide Soap e come
non vorremmo un po’ tutti, noi italiani, ritrovare un modo conviviale dove non
ci siano vomitatori d’odio e pseudopolitici
invasati di rabbia. Satta in questi versi parla anche a noi indicandoci
un modo sereno di vivere che sembrava più comune nell’Italia che si andava
costruendo nel dopoguerra e in un tempo di minor benessere.
Il prezioso librino (poco
più di 100 pagine), molto elegante nell’edizione che porta a fronte il testo
scritto nell’elegante grafìa di Salvatore e quello battuto a macchina per la
stampa, si apre con un gioiellino: sono le pagine introduttive e di spiegazione
di vari componimenti poetici, curate da Valerio Magrelli, ripercorrendo la
storia della corrispondenza a partire da Omero.
Un altro gioiello in
chiusura: foto di famiglia da quella della nozze di Salvatore e Laura nel 1939
davanti alla cattedrale di Trieste, alla loro casa in corso Italia a Genova,
alla festa in costume sardo quando Salvatore
ottenne l’incarico all’Università di Roma e poi gli studi del giurista,
a Genova in via Brigate Partigiane e a Roma in via Cavalier d’Arpino. Una bella
foto del 1964 mostra la famiglia al completo al ritorno a Fiumicino
dall’Etiopia e ne mostra il senso profondo e affettuoso. Anche il valore di una
bella famiglia si trasmette ed è frutto
di educazione.
Giovanni Meriana

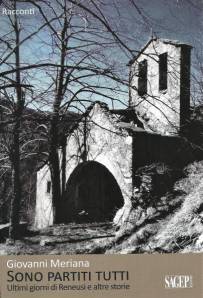
Del professore Giovanni Meriana, 86 anni, nato a
Savignone, già assessore alla cultura a Genova e scrittore di vari libri (ne ho
recensito Pane Azzimo e Memorie di Casa Temolo), metto la
locandina dell’invito per la ri-presentazione di uno dei suoi testi di maggior
successo, Andalò da Savignone.
A fianco la copertina di Sono partiti tutti- Ultimi giorni di Reneusi e altre storie, edito
nel 2010. Il professore me lo ha inviato per il Natale scorso, dono molto
gradito anche perché parla del monte Antola che vedo alto a sinistra andando
per la Valtrebbia a Bobbio, la città della mia mamma.
Dal libro una nota storica che si incontra nelle
pagine iniziali: “Una sentenza dell’imperatore Rodolfo II del 30 novembre 1576
riconosce a Scipione e a Ettore Fieschi, che lo hanno rivendicato da Antonio e
Pagano Doria a seguito della congiura, il territorio di diversi castelli, tra
cui Torriglia e Carrega. Reneusi (ed è la prima volta che se ne parla) è nella
giurisdizione di quest’ultimo”.
Sono partiti tutti
Ultimi giorni di Reneusi e altre storie
Nel
libro, prima dei racconti, questi versi di Giorgio Caproni:
Sono
partiti tutti.
Hanno
spento la luce,
chiuso
la porta, e tutti
(tutti)
se ne sono andati
uno
dopo l’altro.
Soli,
sono
rimasti gli alberi…
Di questo libro affascina
per prima cosa la scrittura: precisa da
apparire scientifica, senza sbavature o inutili divagazioni, pregnante da
dilatare in profondità il significato delle parole. Leggerlo è come fare un
pasto ricco ed esserne del tutto saziati e soddisfatti.
Il testo consta di due
racconti iniziali ed a seguire altri 15 brevi. Per primo quello che dà il
titolo “Gli ultimi giorni di Reneusi”, quindi “Il posto dei ciliegi” che
descrive Ceresole il luogo dove l’autore visse l’infanzia. Pregio del libro è
poter scoprire, ma attraverso brevi cenni personali lungo tutti i racconti,
l’Uomo Giovanni Meriana.
In questo libro sono
cristallizzate le sue esperienze personali importanti, il suo sentire come si è
formato negli anni, imparando da ciò che veniva a conoscere e dai rapporti
umani. Dagli anni della vita in campagna, immaginifici per il linguaggio e per
la fantasia, a quelli dei primi studi come convittore all’Istituto Arecco, alle
esperienze più significative di quando è stato Assessore alla Cultura nella
Giunta del Sindaco Sansa. Questa “geografia di vita” è dominata dal monte Antola
con nella sua cintura i due paesi citati: Reneusi più verso Torriglia e
Valtrebbia e, verso la valle Scrivia, Cerisola (il posto dei ciliegi), il cui
nome sembra derivare dal francese cerise, la ciliegia (in dialetto Serixeua).
Queste parole di nostalgia chiudono il racconto di Cerisole: “Anche i ciliegi
cessarono di rivestire di bianco le quattro case del paese al tempo della
fioritura…” Perché i due paesi dell’Appennino sono abbandonati da più di 60/70
anni dal 2010 data di pubblicazione del libro con la Sagep.
Meriana s’interroga
subito sul perché siano stati fondati in luoghi così impervi: Reneusi “a
ridosso di una costa di monte isolata da mondo”, Cerisola “chiuso in una piega
di monte, forse per difenderlo dalla tramontana gelida”. Per Reneusi, costruito
a oltre mille metri di altezza e lontano dal fondo valle, dove avvenivano gli
scambi commerciali, avanza due ipotesi: “fame di terra” a seguito di gravi
carestie o le scorrerie di pirati barbareschi e saraceni che costringevano
pescatori e marinai della costa a riciclarsi in montanari. Per Cerisola la
fondazione sarebbe stata causata dal maggiorascato: una delle cinque famiglie
storiche del paese, i Repetto, sarebbe venuta dalle Capanne di Marcarolo, un
paese di case sparse su una costa di monte, tra le valli Gorzente e Stura. Le
famiglie delle Capanne erano fittavole degli Spinola, feudatari di tutta la
zona e solo il primogenito maschio poteva succedere nei possedimenti al
capofamiglia deceduto, da ciò l’emigrazione forzata dei figli cadetti. Le altre
quattro famiglie erano dei Valente, cognome dato a qualcuno che “sapeva farsi
valere”. L’unico residente allora rimasto è appunto un Valente. Assaporate
questa foto, intitolata “L’ultimo”.

“Però un paese è tale
quando c’è la gente a renderlo vivo, a coltivare i terreni attorno alle case, a
tenere puliti i boschi, a sorvegliare che gli incendi non facciano un falò dei
casolari in una notte di vento” così scrive Meriana e se ne coglie tutto lo
struggimento.
La stessa nostalgia per
Reneusi che si è spopolato (e di cui l’autore ci descrive la Storia, la Scuola,
il Prete, il Catasto napoleonico (i soldati di Napoleone con l’occupazione
avevano portato il Catasto che definì le proprietà, il Codice civile e la Leva
obbligatoria). Ci parla dei bambini, tra cui c’era sempre “il birba”, quello che messo in un posto
dopo pochi minuti è altrove e per cui nel dialetto di Ceresola c’è la voce
dialettale “l’è afoitò”, termine derivato dalla faina il più astuto e svelto
dei selvatici. Ho voluto riprendere questa voce termine del dialetto di
Ceresola perché la storia di questi paesi abbandonati si rassomiglia. Quei
bimbi, crescendo, li hanno lasciati e grazie allo studio (anche se di poche
classi elementari) hanno potuto scendere a valle per farsi operai nelle fabbriche
o per continuare a studiare come è stato per l’autore stesso. Meriana per
raggiungere “il trenino di Casella” (un racconto del libro porta questo
titolo), che lo portava a Genova, dove in terza media raggiungeva l’Istituto
Arecco di cui poi diventò convittore, racconta: “Quando c’era la neve
sprofondavo talvolta fino al ginocchio, nel viaggio battevo i denti dal freddo
perché le carrozze erano gelide e riuscivo ad asciugarmi solo a sera accanto
alla stufa, ritornato al paese”.
Per Reneusi l’inizio
dello spopolamento inizia con una tragedia: il tragico amore di Davide per
Maria sua cugina prima. Davide era uno di quei bambini che andavano a scuola ma
che crebbe apprezzato soprattutto per l’ingegnosità nel costruire basti tutti
diversi (per trasportare legna, erba, formaggi). Le famiglie erano tutte
imparentate tra loro, ma i genitori di Maria, appunto per scongiurare il
matrimonio, decidono di trasferirsi a valle. Allora quando sul sentiero passa
Maria che se ne sta andando, lui, Davide, per non perderla le spara e poi si
suicida.
Questa fu la fine di
Reneusi: “Partirono tutti” e poi arrivarono gli sciacalli, gitanti-predoni che
si introducevano nelle case abbandonate per saccheggiarle e impadronirsi di
antichi attrezzi e suppellettili, per farne mostra nelle proprie caso o per
venderli ai Musei contadini.
A Reneusi si nascose
Giangiacomo Feltrinelli. Forse perché l’unica testimonianza è dell’amico
Marcello Venturi nel suo libro Tempo
supplementare. Storie del Novecento. Un itinerario umano e civile (Nino Aragno
Editore, 2000).
Meriana ristabilisce per
lui una sorta di giustizia. “La sua morte ha fatto di lui lo zimbello dei
bombaroli senza mestiere, ma nel suo passato assieme agli esplosivi c’è la
Biblioteca Feltrinelli, fondata per guardare al mondo operaio attraverso la
scrittura. In seguito la Casa Editrice
riuscì a far arrivare dalla Russia con viaggio clandestino il dottor
Zivago, cosa per cui il PCI gli tolse la tessera di partito.
Da chi ha preso Meriana,
cosa c’è nel suo Dna? L’ingegnosità del padre che a Ceresola è stato un
contadino innovativo, aperto alle innovazioni tecnologiche da lui divulgate tra
i compaesani: un contadino benestante. Dalla madre la cura, l’attenzione
massima all’universo delle parole che nasce da chi parla il dialetto. Questo era
la sola lingua materna e ne traggo alcune definizioni che riguardano le donne:
“l’è precacinn-a” per la donna svelta, attiva, piena d’iniziativa; “l’è na
scixerboa” per la petulante-ficcanaso, la cui etimologia forse è dalla pianta
infestante della clematide.
Poi, per l’autore, ci
sono stati gli studi: l’Arecco dei Gesuiti, da cui porta in sé negli anni
adulti un’idea chiara di ciò che è bene e ciò che è male, anche un iniziale
integralismo cattolico che poi superò con il dubbio e le domande che l’uomo intelligente
si pone nella ricerca del proprio senso esistenziale; anche l’amore per il
cinema ispiratogli da Padre Arpa che lasciò l’Istituto per dedicarsi al
Cineforum.
Con gli studi e con il
lavoro Meriana visse adolescenza e giovinezza lontano dalla famiglia d’origine
ma ha conservato intatto l’amore per le tradizioni contadine come risalta da
altri racconti dove le leggende si mescolano a ricerche storiche sulla loro
origine. Interessanti ed originali come nel racconto “Lo Scravà” il gigante che aiutava gli ubriachi di notte ad
attraversare lo Scrivia, ed è assimilato a San Cristoforo. Un racconto “I ravioli di Garibaldi” ci introduce in
una storia di famiglia a Montoggio con la nascita della Trattoria Rosin di Tre
Fontane e del Museo storico della Valle Scrivia (Meriana si è occupato
attivamente di Musei). Dell’esperienza di Assessore alla Cultura ricorda quando
nel 1996 si recò ad Uppsala per accompagnare il violino di Paganini per una
serie di concerti nel castello che domina la città. Proprio in una cittadina
vicina trova idee per come si potrebbero rendere più interessanti e
comprensibili al visitatore i Musei contadini. “I conservatori –scrive Meriana
- vedono sovente solo ‘il museo’ e gli oggetti che vi sono collocati, assai
meno il contesto ambientale in cui il museo è sorto”.
Un amico definì l’autore
“un aristocratico” e questo aspetto che sorprese Meriana nel sentirselo dire,
risalta bene in uno dei racconti finali “Sul bus”. Vi vede giovani d’oggi
vocianti con parolacce, con piercing e tatuaggi, sporchi all’apparenza (altre
volte Meriana ha espresso la sua insofferenza ai cattivi odori), in una parola:
“maleducatissimi!”.
Quasi per contrappasso
“La forchetta d’argento”, racconto in cui torna all’amato Monte Antola per far
rivivere la memoria di due signore genovesi, Elena Piaggio e Angiolina
Borgonovo, animate da uno straordinario amore per il nostro entroterra e in
modo particolare per Torriglia e Valtrebbia. Realizzarono il sogno di
costruirvi le loro case ed una è diventata Villa Elena, oggi sede di una Casa
di riposo per anziani, l’altro villino diventò il Rifugio Bensa.
Ho scritto davvero tanto,
decisamente troppo per la misura di una recensione, ma questo libro di
paesaggi, personaggi (gente comune e protagonisti), tradizioni, anche culinarie,
leggende, microstorie e grande Storia è un pasto ricco.
Va centellinato portata
dopo portata.
Giglio Reduzzi

Giglio e la moglie Pierangela - 50 di matrimonio
(sposi il 10 maggio 1962).
- E’
arrivata la svolta
- Il Paese che vorrei
di Giglio Reduzzi
Per il Natale scorso,
puntuale come sempre, Giglio Reduzzi, bergamasco che vive a Genova, ha
pubblicato con Youcanprint questi due
nuovi saggi. In forma di diario, pensieri scritti giorno per giorno, facendo
proprio il detto di sapienza antica “nullus dies sine linea”, che è il miglior
modo per tener viva la mente. E quando i pensieri sono illuminanti, spesso
controcorrente come appunto le riflessioni di Reduzzi, diventano un dono per
gli altri.
Il primo saggio E’ arrivata la svolta va dal 6 aprile al
15 agosto; il secondo Il Paese che vorrei
dal 18 agosto al 13 novembre scorso.
Gli interessi dell’autore
vertono da sempre su Politica e Religione (cioè: vita quotidiana e vita
spirituale), ma la novità è averli messi insieme in queste pagine mentre in
passato dedicava ad essi saggi distinti.
Come precisa lo stesso
Reduzzi la sua passione per la scrittura lo ha portato a comporre circa 40
saggi da quando “è venuta di moda l’auto-pubblicazione e quindi è venuta
meno la difficoltà di trovare un
editore per chi non fosse già famoso”. Un nome noto – aggiungo io - che attira
vendite come per tanti libri sfornati da politici e starlet di Tv o spettacolo che mai ci negano la loro
autobiografia. Ma è biografia degna di questo nome? Cosa mai ci lascia?
Di Giglio ho recensito
per le pagine di Genova de il Giornale
diversi testi, di alcuni ho riportato sul mio Sito 2013 (http://marialuisabressani.wixsite.com/marialuisabressani;
pagina 12-Storia e pagina 14-Autori di “Recensioni
e non solo”).
Cosa apprezzo di Reduzzi
scrittore? La chiarezza cartesiana, l’elegante umorismo, e quanto alle idee mi
trovo in sintonia.
Dei suoi saggi ne cito a
memoria uno fiammeggiante Justice o
Giustizia all’italiana, dedicato alla nostra giustizia politicizzata.
Riguardo a Berlusconi da quando entrò in politica sono stati “28” gli ordini a
comparire (a scomparire!), di cui allora, nel 2011, “23” processi chiusi senza che “mai” fosse dichiarato
colpevole. Gli fu comunque addossata “la propensione alla criminalità”; quasi
“per contrappasso” Reduzzi cita in quel
saggio la mancata estradizione dell’assassino Cesare Battisti. Poiché questa
perdura l’autore torna in queste pagine sul nome di Battisti, affiancandogli
Giulio Regeni ma solo per ricordarci quanto poco peso abbia l’Italia
all’estero. Ritorna pure a criticare gli interminabili processi italiani con
spese enormi ma anche la Corte europea di Strasburgo, cui Berlusconi si è
rivolto: dopo cinque anni non si è ancora pronunciata mentre dovrebbe andar
veloce per non precludergli la corsa politica da leader. Ciò che -con tutta
evidenza- sembra voler fare.
Dei due saggi colpiscono
altre gravi omissioni denunciate dall’autore. I silenzi del Papa: il 7 ottobre
2017 anniversario della battaglia di Lepanto, la Sua mancata partecipazione al
Family Day del 2016. Silenzi come dalla Sinistra –il 9 novembre- sulla caduta
del Muro di Berlino.
Quanto all’altro grande
interesse dell’autore, la Religione, quest’ultimo saggio è dedicato ad un
martire cristiano ignorato: il quindicenne Arslan Masih, studente torturato ed
ucciso in Pakistan perché rifiutava di rinnegare Cristo e diventare musulmano.
Un’altra storia prende al
cuore per chi come lui crede in Famiglia e valore della maternità: la giovane
madre che, sapendo di dover morire, destina 18 doni alla sua bimba incaricando il marito di consegnarglieli ad
ogni compleanno, fino ai 18 anni.
Di Reduzzi ho apprezzato
una volta di più il preciso commento a molti fatti della nostra quotidianità:
dai dolosi incendi estivi, allo studio (vedi il numero chiuso che parrebbe
illegittimo da introdurre alle Facoltà umanistiche mentre queste, a parte
l’insegnamento, non offrono sbocchi professionali), alle Chiese che potrebbero
diventar Musei in cui pagar biglietto
(come già avveniva da tempo nella vicina Jugoslavia), alle vaccinazioni per i
bimbi su cui si discute, non altrettanto su quelle dei migranti.
Questo del gran numero di
migranti, percepito dagli italiani come un’invasione, è punto dolente della
nostra attualità. Il primo dei due saggi inizia con una foto di musulmani,
proni in preghiera davanti al Duomo di Milano; nel secondo Reduzzi ci ricorda
che a Londra ci sono 423 nuove moschee, che nella Chiesa di San Giorgio alla
Messa domenicale ci sono 10 0 20 cristiani mentre la Moschea di Brune Street è
così affollata che i musulmani pregano anche per strada. Però Giglio propone
anche soluzioni sulla gestione dei migranti come dare soldi (nostri ed europei)
ai missionari in Africa più che ai tanti governi corrotti e che li sprecano.

Per l’umorismo, dote
dell’autore, basti questo suo passo: “A differenza di Celentano Grillo ritiene
che con il reddito di cittadinanza anche chi non lavora possa fare l’amore”.
Voglio ancora segnalare
due sue ricerche storiche: L’epopea dei
Caravana (La –tanto derisa- Operosità
Bergamasca)e Dal Brembo al
Mississippi. Nella prima ricorda che la Compagnia dei Caravana (antico nome
della Compagnia Unica del Porto di Genova) si costituì nel 1340 solo con uomini
bergamaschi. Un privilegio loro concesso perché scoppiata una pestilenza solo
facchini bergamaschi seppellirono i cadaveri lasciati in strada. Nella seconda
si deve convenire con lui nel confronto con una burocrazia americana molto più
semplice della nostra.
Da E’ arrivata la svolta foto di Papa Bergoglio eloquenti più delle parole

GIOVANNI FERRERO
(Chicco in famiglia)

Parin - Cav. Ferrero Giacomo 1851-1938
L’ingegner Giovanni
Ferrero, nella sua consueta passeggiata mattutina, ritrova un vecchio collega
ansaldino, neo ingegnere elettrotecnico come lui assunto in Ansaldo nello
stesso anno (1963). Gli racconta qualche aneddoto di famiglia dei tempi andati
e questi gli dice: “perché non scrivi i tuoi ricordi?”.
Il suggerimento dà ali ad
un altro quando, poco tempo prima, un nipotino gli aveva portato un quaderno di
quelli grandi per scrivervi “le sue memorie”. Nome questo un po’ pomposo ma la
maestra – educativa - aveva spiegato che i ricordi degli anziani sono la nostra ricchezza più grande. Si può forse
resistere agli occhi con tante domande
di un bambino? Così l’ingegnere, classe 1937, di getto e in meno di un mese, su
quel grande quaderno dalla copertina verde scrive la storia della sua famiglia
d’origine.
Nel libro, (edito Youcanprint nel 2016), nei
vari capitoli aggiungerà preziose foto (è anche un collezionista) con sapore
del tempo che fu e con quella patina d’antico color seppia ti prende al cuore.
Chicco è il suo soprannome e pure i suoi tre fratelli ebbero dolci appellativi
d’affetto materno: “Mimmo, Dudo e Peppi”.
I ricordi di Chicco iniziano a Valfenera d’Asti, il paese
d’origine della famiglia Ferrero, una trentina di chilometri a sud di Torino.
Il tempo è quello della II guerra mondiale e nella casa avita in via Maestra erano
sfollati i figli del capostipite Parin, ben nove, di cui mancavano solo
Sebastiano e Augusto, parroco e vice-parroco
ad Agliano d’Asti.
“Ti domanderai il
perché”, con questa domanda, riferita agli zoccoletti, Chicco incomincia a
raccontare. “Il fatto è che i miei ricordi iniziano quando d’inverno portavo
gli zoccoletti con la suola di legno e la tomaia di un cuoio nero e rigido…” Ne
conserva ancora uno in bella vista in uno scaffale della biblioteca per non
dimenticare quel tempo in cui suo padre,
che aveva combattuto nella guerra 1915-18 e che nella seconda era
sfollato con la famiglia a Valfenera, confezionava con fatica e precisione
servendosi di forme da calzolaio.
L’autore ci indica come
ha scritto questi ricordi e ci anticipa: “Le mie radici sono le radici di
tutti, uguali e diverse, in esse tutti si possono riconoscere: potevo esser
nato in qualsiasi parte d’Italia, eppure c’è un’identità nel trascorrere di
ricordi che tanti, in essi, possono trovare una piccola parte delle loro”.
Il capostipite della
famiglia è Parin-Giacomo Ferrero (1851-1938) e mentre noi diciamo ai figli:
“saluta il nonno”, allora si diceva “saluta Parin”. Aveva spirito
imprenditoriale: iniziò vendendo ai contadini solfato di rame e guano del Cile
(ottimo concime) girando per la campagna in biroccio e con una pistola a
tamburo per difendersi dai ladri. In un libricino, che il nipote Chicco ha
conservato, annotava le proprietà che
man mano veniva acquistando.
Sposo nel 1877, biondo,
capelli fluenti e ondulati, due occhi azzurri e limpidi; lei, capelli corvini,
con un grande chignon e uno scialle dalle lunghissime frange e rose ricamate.
Lei muore due anni dopo.
Parin si risposa con
Zanet, soprannome piemontese di Giovanna; nel libro anche la foto del menu
delle nozze d’oro con, tra altre squisitezze, “polli novelli alla finanziera, arrosto inglese primaverile, quaglie e
pernici in salmì, e tra i dolci quelle frutte sciroppate di stagione” che erano
parte della tradizione culinaria casalinga.
Nel libro a tutti i nove
figli di Parin sono dedicate poche pagine che ne ricordano e condensano la
vita. Quasi a presentarceli visivamente, prima del racconto, “un santino”, foto che si metteva in morte
per il miglior ricordo di sé.
“In un paese – scrive
– a fine ‘800 tre erano le figure di spicco:
il prete (accompagnava dal battesimo al funerale), il farmacista (del dottore
si faceva a meno ricorrendo a salassi e pozioni, per le nascite bastava la
levatrice) e il notaio, (uomo di legge che dirimeva le questioni sui confini
dei terreni e le eredità)”. Parin, cui
non mancava lungimiranza ed un pizzico di ambizione, ebbe queste tre figure tra
i suoi figli tutti laureati.
Chicco dedica un ritratto
a zia Benedetta, la sorella maggiore, regina della famiglia, che aveva
contribuito ad allevare i fratelli e per questo non si era sposata, ma per gli 80 anni ebbe un mazzo di rose rosse
da un antico pretendente. Particolarmente sentito il ricordo di zio Mario che
gli fu maestro nella “caccia da piuma” (pernici, non lepre) perché gli insegnò
“fatica, rispetto del prossimo, amicizia, obbedienza”. Anche rispetto della
natura e etica della caccia: “non si spara mai ad una quaglia che si alza dal
nido o ad un perniciotto”.
Se Chicco, ad inizio
libro, ha voluto precisare che i suoi sono ricordi di bimbo e non condizionati
dalla tragedia della guerra, non mancano
alcuni episodi esilaranti proprio perché visti dalla parte di un
bambino. Come nel giorno in cui arrivano al podere tre repubblichini in cerca di cibo: quando nei loro discorsi vien
fuori la parola Benito, un cuginetto piccolo dice: “l’hanno ammazzato”. Panico
e suspense, poi la spiegazione: qualche giorno prima era stato macellato il
maialino detto Benito con cui i bambini giocavano. Quando poi ci descrive il
gabinetto alla turca, che magnanimamente Parin metteva a disposizione dei
contadini nei giorni di mercato, Chicco ricorda che fino agli anni ottanta vi campeggiava una scritta, incisa
all’interno della porta di legno da qualche “ospite” per la “perfida Albione”:
“Se gli
inglesi asfissiar volete,
in questo
cesso di peso li mettete”.
C’è anche una cartolina,
inviata nella I guerra mondiale da zio Pinotto a zio Angelo di cui da tempo non
aveva notizie: “Sei vivo o sei morto? Bacioni!”
Il libro si conclude con
la storia dei suoi genitori. Cesare, nato nel 1893, e Lidia nel 1905.
Cesare, ingegnere, negli
anni ’30 con il fratello Angelo (anche lui ingegnere) fonda le Officine Ferrero
che a Savona fu la più importante industria privata del dopoguerra; in quei
tempi di ricostruzione si ampliò anche grazie agli operai, fedelissimi e affezionati a chi dava loro lavoro. Cesare realizzò, insieme ad altri strumenti
ed attrezzi per l’edilizia, un Regolo
Circolare per il calcolo del cemento armato
esposto all’Università d’Ingegneria di Genova.
Lidia era nata in Egitto.
Suo padre Augusto Vignetta, nato a Pinerolo nel 1874 e da giovane vissuto con
la famiglia paterna a Nizza, dopo una giovinezza da giramondo (Palestina, Sud
Africa) si fermò in Egitto a Porto Said dove fondò un’impresa che perforava
pozzi nel deserto per trovare l’acqua. Fu chiamato al Cairo da Re Fuad e messo
a capo dello staff (oggi si direbbe Vice Ministro) del Ministero dei Lavori
Pubblici al Cairo. Si sposò con una ragazza della borghesia maltese: rimase
vedovo con Lidia ragazzina e si trasferì a Torino. Dall’Egitto, allora
protettorato inglese e cosmpolita (erano i tempi del fervore seguito
all’apertura del Canale di Suez) arriva in questa nostra città, importante sì
ma con mentalità ben diversa. Lidia non aveva ancora vent’anni e si chiude in
sé, dedicandosi a migliorare il suo italiano, alla musica, alla pittura con
Casorati. Nella vita, nonostante la cura di quattro figli ben allevati, non
verrà mai meno al suo talento artistico.
Il finale della storia di
famiglia è affidato a Silvio Vignetta, cugino primo di Lidia, che per il suo lavoro ma soprattutto per lo
spirito “cosmopolita”, assorbito nella giovinezza al Cairo con i suoi genitori,
viaggiò poi per tutto il mondo e ci ha lasciato un grande libro Una lunga vita.
Silvio ricorda così la
mamma e il papà di Chicco, sotto la foto di un anniversario di nozze di Cesare
e Lidia nella cornice degli otto nipoti:
“Cara Lidia,
mi manchi, eri la mia sorella maggiore.
Di Cesare
ancora oggi (siamo nel 2005) vedo,
vivo, e
non posso dimenticare come diceva
e faceva
dire le preghiere prima dei pasti.
Io lo faccio ancora oggi

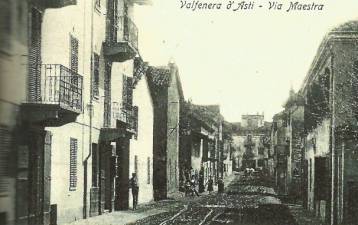
Nozze
Parin 1880 Valfenera In
fondo Casa Ferrero:
“Collassò nel 2001, ne raccolsi un
mattone per ricordo” così ha scritto Giovanni e
di qui la data finale della Storia di famiglia.
(La
casa fu ricostruita dal fratello ing. Augusto
Ferrero)
Oltre ai cari messaggi dei
parenti, questi due sono stati ricevuti e particolarmente condivisi
dall’autore:
Genova, 19 febbraio 2016
Professoressa
Maria Clotilde Giuliani.
“Mi rallegro per la Sua
memoria che è riuscita con attenzione e puntualità a far rivivere in un
bellissimo affresco figure davvero indimenticabili come Parin, adamantino
patriarca, gli zii operosi e geniali, le dolci zie, i genitori forti e tenaci,
Valfenera la casa del cuore.
Sullo sfondo la società
borghese che dalla campagna si apre alla città con quella imprenditoria e
quella originalità che ne ha fatto la spina dorsale ed economica dell’Italia e
di grande interesse anche le pagine sulla Guerra, cariche di preoccupazioni e
di disagi per gli adulti e così serene per i bambini.
I suoi sei nipotini
saranno sempre orgogliosi e riconoscenti per avere un Nonno come Lei che, oltre
ad essere un ingegnere di notevole rilievo, scrive tanto bene e dimostra una
delicatezza e una sensibilità non comuni. Il Suo libro è un grande dono
d’amore”.
28 agosto 2016
Ingegner
Fabio Capocaccia
“All’inizio ho pensato ad
un libro scritto per i nipoti perché non si perda la memoria della famiglia,
una specie di trattato familiare pieno di nomi e di fatti, utile solo ai
discendenti…
Poi devo confessare che
sono rimasto preso dalla forza di questa famiglia, dallo straordinario disegno
del Padre Padrone (o meglio Parin), dalla ricostruzione fedele delle vicende
dei nostri nonni, che un po’ tutti si somigliano. E poi la guerra e il rapporto
dei bambini con i tedeschi e i partigiani (sono stato sfollato a Roccagrimalda,
ed ero affascinato dalla guerra senza capire i drammi, le differenze e le
contraddizioni, ma per me quello è stato un periodo bello e molto formativo, mi
facevo i giocattoli da solo anch’io, che poi erano fucili, camion e jeep)…
Certe volte le storie
vere hanno una forza che nessun romanzo di fantasia riuscirebbe a creare. Ho
poi trovato delle semplici (e divertenti) verità: il farmacista vale più del medico,
il notaio più dell’avvocato, e almeno un prete nelle grandi famiglie ci vuole
(vedi anche i Costa). E poi l’incontro tra papà e mamma al Valentino è un vero
capolavoro…: ”ma di che cosa dobbiamo parlare?”. Penso ai ragazzi di oggi…
Insomma ho passato
qualche bel momento e volevo dirtelo…
Ho poi apprezzato il tono
volutamente dimesso, l’understatement, il contrario della retorica.
Quando, alla fine, del
Papà Cesare bisogna per forza che vengano fuori le qualità, che qualcuno abbia
il coraggio di dirlo, allora si fa parlare il cugino Silvio…
Proprio un bel libro.
Un caro saluto
Fabio
Una lunga vita
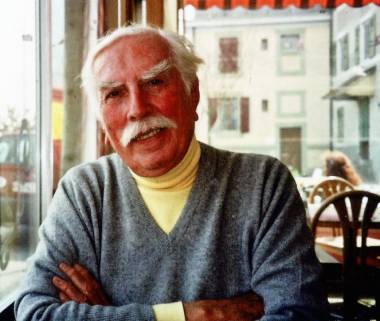
Silvio Vignetta 1920-2011
Nome in famiglia “Sev acronimo di Silvio Edgardo Vignetta
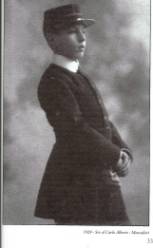


Sev al Carlo Alberto Sev campione di scherma Sev-M/n Victoria
di
Moncalieri 1929 1937 1937
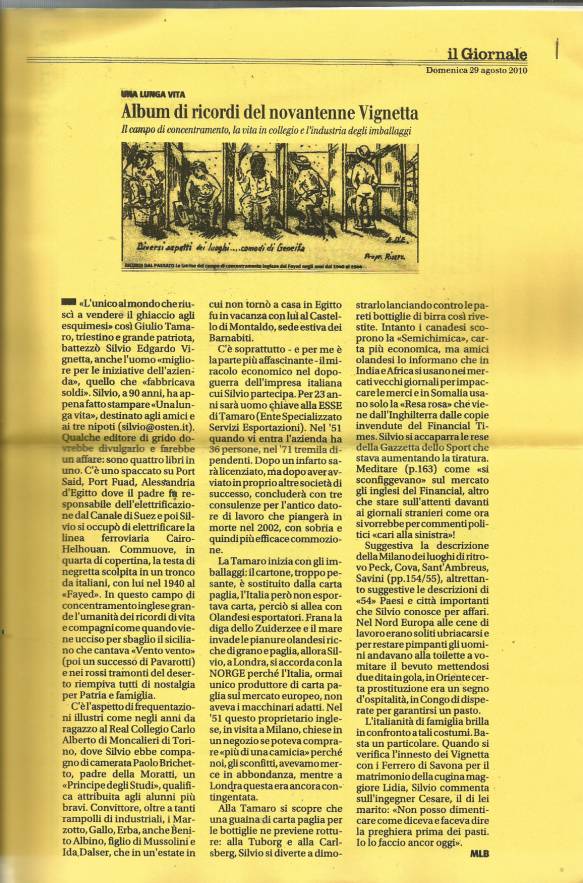
E questa recensione
così ben rilevata dallo sfondo giallo è come me l’ha rimandata Silvio
come ringraziamento.
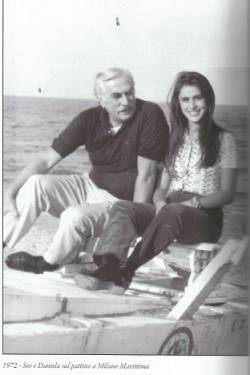
1972 Silvio e la figlia Daniela
Grazia Zerbi, seconda moglie di Silvio, è
anch’essa scrittrice e allego due recensioni da me scritte per lei, anteponendo
la sua foto sempre dal libro Una lunga vita.
Grazia Zerbi

L’Affresco
L’Affresco di Grazia Zerbi (Runde Taarn Edizioni,
Gerenzano di Varese) rivela una scrittrice autentica e la presentazione dei
cinque racconti sottolinea che rivendicano “la centralità dell’Altra Metà del
Cielo”. Zerbi ha scritto Diario per caso
(2001) e Storia di Martita (2003). A chi li voglia leggere
comunicheranno una visione al femminile, intimista, profonda. L’autrice vive
soprattutto a Bordighera, poco ormai a Saronno, e lo scenario è dominato dal
paesaggio ligure-francese: “Lunghe onde verde-dorato di viti, macchie argentate
d’uliveti”. La prima voce è il rumore del mare, il saluto della Riviera a chi viene dalla nebbia. Su questo
sfondo una domanda accomuna le donne: “Io? Cosa significo in tanta
compiutezza?”
Le trame riguardano: una
moglie, stanca di una quotidianità cui non si era mai ribellata, che fugge al
mare; una madre che va al mare ma per sottrarsi al ricordo della figlia
giovanissima, schiantata in moto in “un autunno di foglie rosse come il
sangue”; una cinquantenne che vive il distacco d’amore con un ragazzo giovane;
due sposi paghi di sé e della quieta normalità; “La Charmeuse” (nome dato ad
una casa al mare) dedicato al padre.
Nei racconti all’inquietudine
esistenziale della donna moderna fa da contraltare la saggezza degli umili: di
Maddalena che aiuta in casa e un giorno arriva con un mazzo d’alloro, ulivo,
cipresso e ortensie violette suggerendo l’affresco che intitola il libro; di
Nanni, una tata che ha allevato la mamma di Anna, la ragazza morta in moto.
Delle stelle diceva che le vediamo rovesciate. “Brillano dall’altra parte mille
volte di più, là dove stanno tutti i morti.”
A fianco di queste donne,
le giovani: figlie “che vale la pena di vivere, come scatole a sorpresa delle
quali almeno una riscatterà le deludenti”, figlie aggressive che rifiutano come
“banale, statico” l’insegnamento, un ruolo tradizionale. “Cosa c’è di statico
nel nutrire le menti dei bambini, nell’insegnare il gusto della parola?” si
chiede una madre che vive immersa da sottomarino nella “banalità della
giornata”, che dell’amore con il marito pensa: “Siamo tutti e due miti, miti
l’uno verso l’altro, con il prossimo, con gli accadimenti”. E dei ricordi per
chi non è più: “Credo anche la resurrezione sia tutta lì, nel ricordare”. Se il
suicidio sembra talvolta unica sortita dalla vita, ogni esistenza s’inscrive
nella perfezione di un cerchio, come in un arcobaleno: dal cuore della terra al
sommo cielo.
L’ultimo racconto di questa
signora d’animo è per il padre, quando lo veglia in morte. Vorrebbe spalancare
le finestre per far entrare la luce, perché lo ripensa a “La Charmeuse”, vitalissimo sulla battigia con la camicia come una
vela in vacanze di una lunga felicità di famiglia. In questo racconto il
ricordo di un disegno dai colori accesi che fece bambina. La sorella maggiore
lo criticò senza capire che l’irrazionale ci fa vedere di là del naso. Pregio
del libro una scrittura cromatica come il caleidoscopio dei sentimenti. Tenera
la storia del cagnolino Tom di cui, in stazione, un ragazzo nel partire per
militare le mise in mano il guinzaglio: “Non ho a chi darlo”. Il padre, che lei
aspettava, sceso dal treno lo prese in braccio, accettandolo. Questo ha
significato l’Altra Metà del Cielo: affetti, colori, particolari a creare
l’affresco del nostro vivere.
Forse Grazia Zerbi mi è
rimasta così simpatica anche perché con il marito (come i Biagini) sono una
colta coppia di scrittori. Il suo, Silvio E. Vignetta, 90 anni, è autore di Una lunga vita con la storia di tanta
industria italiana del “boom” e degli eventi che hanno percorso tutto il
Novecento. Forse perché, in controcanto con le arrabbiate d’oggi, mi ha detto:
“A dispetto di questo così conclamato inaridimento dello spirito, non smetterò
di credere che ci sarà, nel tempo, un recupero di valori fondanti della vita”.
E mi ha chiesto una critica vera, “se no, non serve”: umiltà di una vera
scrittrice!
Agnese e i continenti
di Grazia Zerbi
Agnese e i Continenti di
Grazia Zerbi, il sesto e più recente raccolta di racconti o versi di un’intensa
autrice lombarda, si apre con una storia d’incantevole freschezza.
Agnese che dà il titolo
al libro è una “ragazza” invecchiata con un padre che scriveva libri, aveva
visitato quasi ogni angolo del mondo e che poi le raccontava “mari e
continenti”.
A 70 anni ormai compiuti,
donna sola ma con cuore di ragazza, considerata un po’ tocca per la sua
riservatezza “asociale”, Agnese riempie lo zainetto e decide di raggiungere il
mai visto per comprare una barca (ha messo da parte i soldi) e con questa
raggiungere i Continenti dei fantastici racconti del padre.
Inizia così, con
disarmante candore, la sua avventura…
Seguono una decina di
storie, quasi tutte con per titolo un nome femminile. Esplorano il loro mondo,
aprendoci continenti di attese, speranze, disillusioni.
Al loro fianco spesso
uomini, anche intelligenti però suggenti, quasi misteriosi nel voler custodire
egoismi privati o tradimenti.
Le donne sono i
Continenti e forse l’uomo è il Mare.
I racconti infatti
ondeggiano tra due poli: attesa di come le donne vorrebbero le cose fossero e
mistero di come gli uomini sfuggano, talvolta distruggendo, talvolta lasciando
uno spiraglio al sogno. A far da sottofondo ma anche da protagonista il Mare
con la sua voce dalle tante sfumature.
L’acqua che scorre, vita
perché “quell’acqua scura non sta ferma mai” per riecheggiare parole di una
canzone a me cara (di Bruno Lauzi) ritorna in un racconto particolare, dedicato
al padre dell’autrice con titolo “1915-1918”.
Narra la storia del
sergente Berzi (anagramma indubbio di Zerbi) che nella I Guerra mondiale si era
battuto per un ideale, l’Irredentismo ed era stato salvato da un soldatino,
gettatosi su di lui e dilaniato dalla granata da cui voleva proteggerlo. Come
superare il lutto di quella morte continuando a vivere?
Ecco invece che nel
racconto e soprattutto nella mente di Berzi si sovrappongono misteriosamente le
acque di due fiumi, il Danubio dove, ripensando alla guerra, allora si trovava
e il Piave degli anni del conflitto: l’acqua
che scorre diventa acqua di vita e accende la speranza di poter continuare.
A questo racconto quasi
di chiusura all’essenziale libretto ne seguono altri due connotativi degli
affetti di Grazia.
“Ricordo tutto”, dedicato
la marito Silvio che non è più, di cui Lei dice: “Il tuo amore profondo e
paziente”. Ultimo di questa triade “Li penso mano nella mano” dedicato ai
genitori e al loro amore iniziato con un pacchetto di caldarroste che a Lei
sfugge di mano e che Lui aiuta a raccogliere”.
Anzi in questo spazio
così umano irrompe ancora un affetto: Foxy, un cagnolino chiamato così perché
ha l’aspetto di volpe. Anche lui un illuso, un rifiutato e tradito come diverse
donne dei precedenti racconti, ma che gettato in mare da chi voleva liberarsi
di lui, giunto a riva trova una donna capace di amarlo: Lui, fiero
dell’appartenenza incontrata, grida al Mare che lo aveva salvato con onde
pronte ad accompagnarlo a riva come Nereidi: “Mi chiamo Foxy!”
Da tutti i racconti ci
nascono riflessioni profonde, che ci appaiono naturali, senza pedanteria
alcuna. Uno stile che quasi ci culla con immagini stupende di una natura
sovrastante nella sua eternità bella: le colline d’Inghilterra viola di erica,
un prato di betulle dritte come ceri votivi accesi al cielo, un balcone di
gerani a dimostrare che “l’amore non si stanca mai della dedizione che ci
chiede”. Credo questa sia la chiave più vera del libro: Grazia è stata
fortunata, ha avuto amore lo ha ritornato.
Così avendo
inaugurato in questa pagina recensioni a libi di donne ne inserisco altre due,
a me particolarmente care, dato che mi riportano la nostalgia della mia terra
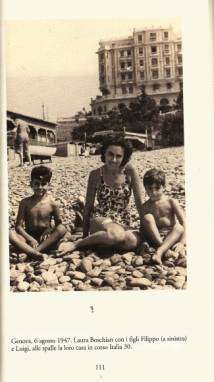
Laura Boschian Satta e i figli a Genova
Diari della
triestina Laura Boschian
(1939-1959)
Della triestina Laura
Boschian sono due diari, di molte pagine: il primo riguarda la sua infanzia e
giovinezza Trieste (1915/’39); il secondo va dal matrimonio nel ‘39 con
Salvatore Satta, al ‘59 quando muore suo padre Arturo Boschian, fondatore a
Trieste di una Ditta di “Lane e cotoni”, poi al ’60 con il trasferimento da
Genova a Roma.
Per Ilisso nel 1977 uscì Il Giorno del Giudizio del marito, che
gli diede gran fama di scrittore: storia di una famiglia di Nuoro tra
Ottocento/Novecento in cui ogni figura rievocata dal passato chiede di essere
ascoltata e compresa in vista di quel giudizio finale che ci tocca nella verità
della morte. Il libro fu rilevato da Adelphi nel 1979.
Il primo volume di questo
diario della moglie Laura che iniziò da giovane secondo quel motto antico
“nullus dies sine linea” è un atto d’amore verso Trieste, la sua città natale,
che con razionalità connota fin dalla prime pagine nelle sue coordinate di
paesaggio e territorio. Inizia con le passeggiate che lei e il futuro marito,
conosciuto a Padova dove lui era docente e lei assistente alla Cattedra di
Letteratura Russa, facevano nei dintorni di Trieste.
Scrive:
<<Visitavamo Barcola che è un prolungamento della città sul mare, Opcina
succursale della città sul Carso, Conconello sulla collina più alta, Muggia ancora sul mare>>.
Uno splendido incipit che
connota la città così come si presenta e che arricchisce di particolari: i
depositi di agrumi che allora erano
insediati al piano terra di ogni casa,
la bora voce di Trieste, i cestini di lamponi che ad agosto si
coglievano in Carso. Laura, vera “osservatora”, come si compiaceva di definirsi
Lalla Romano grande scrittrice
ricordando questo complimento rivoltole da un uomo semplice, ci dà
particolari di moda delle donne d’allora: lo strangolin, rigido e alto nastro bianco che fasciava il collo della
nonna materna (della nobile famiglia Machlig, vedova poco più che trentenne,
che poi mantenne sé e la figlia insegnando il ricamo alle ragazze delle
famiglie bene), ma anche notizie poco ricordate pur se dei Caffè di Trieste in
molti hanno scritto. Lei precisa che vi si leggevano i giornali in tre lingue,
usanza dell’Impero Austro-Ungarico, in voga a Vienna e Budapest.
In questo paesaggio anche
la storia di famiglia, che non è destinata solo ai due figli e ai cinque nipoti
come crede Laura da nonna, ma interessa per i costumi del tempo: il controllo
scolastico dei pidocchi, la cerimonia del tè pomeridiano, i balli delle
diciottenni (e Laura non frivola, anzi
quasi selvatica, seguiva queste usanze solo per non scontentare mamma e nonna).
Una storia di famiglia che si allarga alle case di villeggiatura che il padre
veniva acquistando.
E in una di queste, a
Villa Decani vicino a Capodistria, Laura tornerà un giorno incontrando di nuovo
il vecchio slavo Carlo (il manente potremmo definirlo), commovendolo e
commovendoci. Per lui scrive una delle tante frasi incisive, fulminee che
caratterizzano il suo stile: <<Al di là di ogni problema sociale
nazionale e infine politico, Carlo da giovane aveva amato la sua dura giornata
di contadino e (nel nostro incontro) la sua anima semplice era emersa per un
attimo, luce che fa l’uomo uomo>>.
Tante queste sue frasi folgoranti.
Perle di saggezza come quando nel secondo tomo parlerà dei “delinquenti di oggi
e di ieri”: <<Venuta la pace (dopo
l’ultima guerra) il male era esaurito, dopo 50 anni di pace il male è virulento>>.
Tra i personaggi della
sua famiglia d’origine dove non mancava certo l’amore ma c’era conflittualità
proprio tra i coniugi, la madre di famiglia aristocratica e il padre d’origine
contadina, Laura sceglie la nonna materna che “si era fatta o piuttosto rifatta
da sé” e il “babbo”: due persone che si rassomigliavano, “imprenditori di sé”.
In questo ambiente nasce
il suo amore per lo studio che va oltre la sua natura di bimba un po’ ribelle
(nel senso che pensava certe regole vecchie e superate, da sostituire con altre
migliori). Amore che la porta al Liceo Dante di Trieste dove un “maestro”
rimane per lei indimenticabile: Stuparich. <<Uscir vivo dalla guerra del
‘15 con una medaglia d’oro non era cosa da tutti>>, scrive di lui e poi: <<Stuparich aveva un cuore di fiamma, con lui
imparammo a diventar persone>>.
Consegue la laurea in
letteratura russa, la borsa di studio a Praga. Nel 1952 quando il suo figlio
più piccolo Gino, che ha fortemente voluto la pubblicazione di queste pagine,
non aveva ancora 10 anni, Laura ricordandosi che era il centenario di Gogol
ricontatta a Praga il suo professore Lo Gatto, fondatore della slavistica italiana,
e riprende gli studi. Vincerà un
concorso, pubblicherà diversi libri sul Settecento e Ottocento russo, sulla
Vita di Lenin; su Dalla Santa Russia
all’Urss (1905-1924). Un destino voluto da tutti; e molti saggi.
Nel secondo volume è
centrale l’esperienza della guerra con il primo bombardamento su Genova dal
porto, con un primo rifugio a casa di un fratello di Satta, ingegnere che
viveva a Sori, quindi alla Colombarola, villa degli Scerni presso Parma. Quando
gli Scerni vollero tornare da Bressanone in questa villa capirono di essere
stati utilizzati perché i tedeschi requisivano le case sfitte.
In questo volume dove ripercorriamo la nascita dei due figli
e della loro vita di bimbi risplendono due frasi: <<Noi e basta in un intenso circuito d’amore>>(così sentiva
Laura riguardo la felicità del suo matrimonio) e poi <<le letture in comune, forse il lusso più
grande concessomi dalla vita>>.(Il marito Salvatore, che in famiglia
è chiamato Bob, a sera leggeva un libro a Lei che ascoltava lavorando a maglia
o ricamando, in seguito anche ai figli).
Del tempo di guerra un
episodio affonda nel mistero: Vittorio, figlio del fratello di Satta che viveva
a Sori e pilota (nei fascisti di Salò aveva riconosciuto l’ultimo lembo di
Patria) precipita con il suo aereo. In
quel momento Filippo, quattro anni, figlio maggiore di Satta, alza gli occhi al
cielo infuocato dal tramonto e dice: <<Vedo una stella, è la stella di zio Vittorio in cielo>>.
Le tante pagine sono un
onore in più a questa bella e saggia triestina che ha anteposto a tutto studio
e famiglia e con il coraggio della verità ci ha restituito notizie e
personaggi.
I due testi scorrono come
un largo fiume ma oggi noi siamo condizionati a libri brevi perciò, per una
lettura più moderna, uno studente molto dotato o un bravo studioso dovrebbero
riprenderli in mano per una tesi universitaria o un restyling che salvasse
l’essenziale.
Purtroppo di tutte le
persone di famiglia tanto care, che scrivendo non possiamo staccarci da esse,
ad altri poco importa, mentre costumi, luoghi amati, ideali, nel tempo restano
d’interesse per i tanti.
Gli Oleandri di Dubrovnik
di Maria Rosaria Dominis
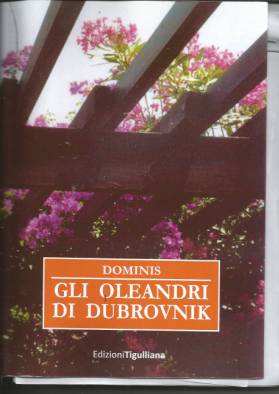 “Francesca si era incamminata verso
quell’uscio aperto: non avrebbe mai saputo quanto era bella in quel momento, in
quella luce di tramonto con quei barbagli rossi nei capelli. Si fermò davanti a
Nicolò ad occhi spalancati e lui: ‘Non è come pensi’. Lei: ‘Allora è come
sembra’.”
“Francesca si era incamminata verso
quell’uscio aperto: non avrebbe mai saputo quanto era bella in quel momento, in
quella luce di tramonto con quei barbagli rossi nei capelli. Si fermò davanti a
Nicolò ad occhi spalancati e lui: ‘Non è come pensi’. Lei: ‘Allora è come
sembra’.”
Così, “fiammeggiante”, ci
appare Francesca, la prima delle tre donne protagoniste di altrettanti racconti
de Gli Oleandri di Dubrovnik di Maria
Rosaria Dominis (2016, Edizioni
Tigulliana), ambientate nel ‘900. Francesca,
slanciata, vita sottile, eleganza anticonformista, ha sposato il figlio
del marchese Tommaso Serra. Rimane presto vedova del marito che condivideva i
suoi interessi di giovane attrice. Dopo la morte precoce di questi, Francesca
vive con la figlia Saveria e per l’appunto
con il nonno Tommaso che la faceva sentire “dignitosa e serena”. Per avere un
minimo di indipendenza economica organizza una sorta di doposcuola per bambini,
ma, quando il suocero muore all’improvviso, al funerale incontra il nobile
parentado che aveva messo al bando Tommaso, in quanto sposo della bambinaia più
anziana di lui. Nel bisogno però la famiglia contava ancora molto. Al funerale
Francesca s’innamora del ricco cugino Nicolò, ma il momento da cui ho iniziato
è quando lei lo scopre uomo diverso da come pensava e troppo fuori dalle
convenzioni. Un’amica americana, dato
che Nicolò, poi affetto da senilità precoce, continuerà a prendersi cura di lei
e di Saveria, le dice: “Salvi tutto quello che ti preme, cioè i vantaggi delle
cortigiane e l’educazione beghina”.
Ho anticipato l’intreccio
– e me ne scuso - per far capire come il romanzo di Maria Rosaria Dominis sia
di costume, con focus sulla mentalità femminile in mutamento: donne che
aspirano all’indipendenza però si appoggiano agli uomini, meglio se importanti.
Le tre storie si svolgono
in un’immaginaria isola di Dalmazia, dall’autrice soprannominata “Corallo” per
i caldi colori, che con l’indicazione dei posti circostanti può essere individuabile.
Il secondo racconto, il
più amato dai lettori per la modernità del personaggio, rappresenta una
giovanissima Lidia che a Corallo è demandata a seguire i lavori di
ristrutturazione di una villa di famiglia. Lidia si butta a capofitto in una
storia d’amore con chi l’ha fatta sentire importante dandole il compito ma,
tradita oltre da lui, (gli uomini del romanzo appaiono “succubi” del fascino
delle donne), e da chi l’aveva allevata e doveva proteggerla, scappa sul motorino. Quando ad una curva
vola fuori strada, si rivolge mentalmente a loro che la inseguivano:
“Penseranno che l’ho fatto apposta”. Malinconia per una morte giovane!
La terza storia è
dedicata a Marianna, nata in un luogo
per mare vicinissimo a Corallo. Ha fatto in Italia un buon matrimonio,
però è succube del marito egocentrico e supponente. Nella sua terra ritrova l’identità perduta.
Marianna è così
importante nel libro (infatti il racconto di lei è incastrato alle altre storie
prima della conclusione) perché l’autrice, che rifiuta ogni lettura
autobiografica, le dona suoi pensieri.
“Sono italiana”, scrive
Rosaria nella prefazione, “e vorrei che la mia terra lo fosse ma non lo è.
Geograficamente non lo è, (lo è, almeno un po’, per la Storia, faccio
osservare). “Sentimentalmente, come molte terre di confine, è come il popolo la
sente.
“E’ il popolo che conta;
e il popolo allora, era dalmata, semplicemente. I dalmati erano dalmati e
basta”.
Attraverso Marianna
l’autrice parla di quel suo popolo che conobbe prima dell’esodo. Quasi
certamente l’autobiografia c’è nel suo altro bel romanzo La panchina di pietra (De Ferrari Editore) nel personaggio di
Flora, bimba croata, arrivata in Italia, viaggiando su un carro bestiame in un
Paese del Piemonte non lontano da Torino. Da privilegiata è diventata povera,
ma si convince che “agire sia meglio che subire” e i libri le aprono mondi.
Nella prefazione agli Oleandri, Rosaria parla del padre di
Marianna che non era stato volontario di guerra e che aveva raggiunto i monti
del Kordun, costretto da un gruppo di partigiani scesi sulla costa alla ricerca
di un medico.
Per questo padre dottore
come per il padre stesso di Rosaria, “imprenditore e di grande famiglia”, vale
un’osservazione dell’autrice: “Nel 1947, dopo la confisca dei beni tra gli
italiani che partirono, c’era anche una classe dirigente che aveva costruito
fabbriche, imprese, alberghi”.
Nel libro affascina la
sottolineatura della vita in comune del popolo della costa: “Non erano
italiani, croati, turchi, sloveni o serbi ed erano un po’ di tutto questo.
Tutti mangiavamo kašica col latte nelle
sere d’inverno e preparavamo focacce con lo sciroppo di rose a Pasqua. Alle basse maree, a febbraio, tutto il paese
raccoglieva conchiglie e preparava il sugo alla polenta”.
Mi trasporto ad una
pagina indimenticabile (la 263): “Pochi
sanno che il mare dà il meglio di sé d’inverno. In gennaio è un’esperienza
dolcissima sostare al riparo di uno scoglio, mentre il sole intiepidisce il
viso…, in febbraio le basse maree scoprono fondali segreti e panorami
selvaggi”.
“Una sola cosa emerge dai
miei scritti” dice l’autrice “la mia cocente nostalgia per la terra di Dalmazia
aspra, profumata e indimenticabile”.
Quanto allo stile il suo
amore per particolari connotativi mi riporta alla mente come Lalla Romano
definisce se stessa, con parole di un anziano che la conobbe bambina: “E’
un’osservatora!”. Grande pregio di uno scrittore saper trasporre la realtà con
esatta osservazione di vita e natura.

Questo è il retro della copertina del libro sempre con foto scattata da
Maria Rosaria
La Senaide di Cesare Quadri
a cura della figlia
Ester

“Basta invocare Calliope
sdolcinata” così Cesare Quadri introduce il suo poemetto epico La Senaide e precisa di voler rivolgersi
a Marte. Calliope, ormai per usura d’anni, ha la “classica faccia da strega” e
di lei il vate “se ne frega”. Nella sestina successiva: “Canto i massacri,
l’orge, le congiure/ gli stupri, le violenze, gli assassini,/ canto la dura
guerra e le avventure…/canto frati, donnacce, traditori,/villani, mercanti e
trovadori”.
La guerra è tra i Senesi,
Pisani, Fiorentini “quando la gente a nugoli moriva/ fuori dal letto” per
guerre e prepotenze dei più forti che avrebbero ammazzato “anche i già morti”.
In questo verso, sa subito, brilla l’umorismo dell’autore e penso anche ad un
successivo e molto ironico “duello con le patate”: “le patate,/ se ti piglian
colà dove sé nudo/ ti tribbian come fossero sassate…”.
Pregi del poemetto epico:
il ritmo dei versi e il linguaggio forte,
a volte scanzonato come era di un autore giovane e un po’ goliardo. Si
ricordi la fortuna che a Genova ebbe nei suoi anni d’oro La Baistrocchi, con
testi e recita di studenti. Cesare scrisse nel 1943, studente presso la Facoltà di Legge a Siena. Aveva 21 anni e fu richiamato in guerra, poi
fatto prigioniero dai tedeschi, infine deportato in Germania
Per il ritmo basta questo
verso: “dagli al pisano a morte! picchia! ammazza!”. Per la forza del
linguaggio bastano questi tre verbi per quel che può fare in battaglia un forcone:
“sburra, strippa, ammazza”.
Altro pregio l’attualità
di quanto da lui scritto che arriva ad oggi, per fortuna non per le guerre, ma
per notazioni come quella sulla “bella Firenze tutta in fiore” e sembra un
tweet recente di Renzi o quando il Re di Napoli interviene a metter pace tra
Granduca e Chiesa, come un Trump odierno tra le due Coree. Prima tuoni e
fulmini, poi la stretta di mano. Per la cronaca la vicenda narrata Da Cesare
vien fatto risalire alla seconda metà dell’Ottocento.
Tra colpi di scena continui,
con molto umorismo si capisce e si può gustare, ma prima è indispensabile
leggere l’introduzione di Cesare stesso che inizia così:
Introduzione per gli ignoranti. (Franco, per esempio).
La vicenda – secondo
l’autore – risale al 1840 quando un diciottenne, Carlo Tuba, poeta e pittore,
arriva in Siena e prende a frequentare i più illustri uomini di scienza e
letterati come il Castragatti, di cui diviene discepolo prediletto. Tuba per i
suoi scritti entra in contrasto con la Chiesa. Costretto all’esilio sperimenta
(novello Dante) “quanto sappia di sal lo pane dei primi alberghi di Parigi,
Londra, Alessandria, Costantinopoli, New York, ecc.”
Tuba nei momenti d’ozio
commerciava proficuamente in agrumi e quindi poteva permettersi tali lussuose
location. Decise poi di abitare a Madrid dove conobbe il medico e poeta, Palle
il vecchio, che divenne suo discepolo prediletto.
Colpo di scena: il
Granduca di Toscana, in rotta anche lui con la Chiesa, richiama il Tuba che
conduce con sé Palle. Tuba scrive, su desiderio del Granduca, la Toscana scatenata, e viene da lui
nominato Sovrintendente alle Finanze ed ai Lavori pubblici.
Nel 1875 Tuba pubblica La
Senaide e nel 1903 “la magnifica opera scientifica”, in 17 volumi “Il poema
comico ovvero del concetto”. Infine nel 1942 Palle per il trentennale della
morte di Tuba pubblica l’edizione della Senaide “purgata, corretta ed aggiunta
di un canto e mezzo”.
Nell’introduzione è anche
da notare il nome di Castragatti che ritorna nella Dedica messa alla fine del
poemetto. A lui, che oltre ad altre mirabolanti qualifiche, ha pure quella di
Ispettore generale delle latrine pubblica e privata, Tuba voleva dedicare se il
Catragatti gli avesse fatto “il meschino prestito di lire venti”. Ma prestito
rifiutato, la Dedica è per chi voglia farlo.
Non manca nel poemetto
l’Amore, così importante per un diciottenne, quando nel Canto III due cavalier
Chiantini rendono visita a una vicina, gran dama in Castelina, dove
s’innamorano entrambi di Baciasole.
Questa era la perfida
maga fiorentina di nome Zelmina, e quasi novella Circe, aveva il compito di
stregare i due “bischeri di Siena”. In breve Baciasole-Zelmina li fa
prigionieri ma nel Canto IV mentre li porta verso Firenze, uno dei due, Emilio, non cessa di ammirare “il bel visino
e la graziosa e soda personcina” della maga. Coup de Théâtre: dopo uno scambio
di improperi, Baciasole gli rivela di essere “ancora come mamma la fece” e non
la sposa del Duca, ma sua nipote per cui non poteva essere l“amante dello zio”.
C’è anche la parodia dell’incantamento
d’amore che governava gli epici paladini, perché il cavaliere Franco De Rossi
deve far sollevare gli aretini coinvolgendoli nella guerra. Travestito da
frate, arriva ad un castello dove chiede ospitalità. Viene scoperto e il
castellano, che ha una figlia molto brutta, gli impone il matrimonio con lei
Dopo la prima notte di nozze Franco scappa come una saetta fino al Volga e per
questo suo viaggio così lontano mi ricorda un po’ Astolfo sulla luna dell’Orlando Furioso.
Il manoscritto di Cesare
Quadri, che in tempo di pace passò con lui da Siena a Genova, è stato
pubblicato dalla figlia Ester: perché il padre “per indole mai concludeva le
sue cose” o forse per il rimpianto indelebile che un genitore amato lascia nei
figli quando muore d’improvviso senza che si sia potuto ritornargli tante
parole d’affetto non dette.
Ha fatto molto bene Ester
a proporre questa pubblicazione, con affetto di figlia certo, ma perché La
Senaide ha uno smalto sempre attuale: la freschezza inventiva che solo i
giovani sanno portare e spunti di riflessione fino ai giorni nostri. Ester si propone ora di pubblicare anche i
diari del padre dalla prigionia.
(I molti disegni del
libro, anch’essi spesso divertenti come vignette, sono di Cesare Quadri: ne
allego uno “I cavalieri” della fine del Canto III e la bandiera del Granducato
di Toscana).